Dalla scomparsa delle “lucciole” a una politica della sopravvivenza
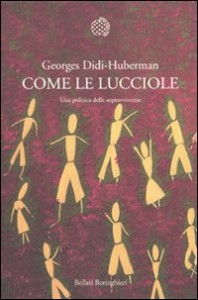 Tra le diverse costellazioni di pensiero che hanno caratterizzato gli ultimi decenni del Novecento, è indubitabile che la “condizione postmoderna”, profetizzata a metà degli anni ’70 da François Lyotard –cui faceva eco in Italia il “pensiero debole” di Vattimo e altri–, sia stata quella che più tutte è riuscita a incidere nella coscienza del tempo, nelle dinamiche culturali ed estetiche di quel tornante di fine secolo, probabilmente perché le plurali tonalità soggettive dell’epoca, contrassegnate dalla percezione di un tramonto delle utopie e di un “senso della fine”, meglio corrispondevano a quella sentenza o “dichiarazione di morte” che sia Lyotard sia Vattimo avevano pronunciato nei confronti della Modernità e dei suoi “grandi racconti” o metanarrazioni. La perentoria presa d’atto della “fine del Moderno” investiva le figure, i codici e gli orizzonti che avevano segnato l’affermazione dell’epoca lungo tre secoli: per cui, adesso, venendo essa meno, trascinava con sé come detriti oramai consunti quei corollari e dispositivi che le avevano consentito di dispiegare la sua “metafisica influente”: il soggetto, la politica, lo Stato, l’idea di progresso, il senso della storia, il carattere futurizzante della temporalità.
Tra le diverse costellazioni di pensiero che hanno caratterizzato gli ultimi decenni del Novecento, è indubitabile che la “condizione postmoderna”, profetizzata a metà degli anni ’70 da François Lyotard –cui faceva eco in Italia il “pensiero debole” di Vattimo e altri–, sia stata quella che più tutte è riuscita a incidere nella coscienza del tempo, nelle dinamiche culturali ed estetiche di quel tornante di fine secolo, probabilmente perché le plurali tonalità soggettive dell’epoca, contrassegnate dalla percezione di un tramonto delle utopie e di un “senso della fine”, meglio corrispondevano a quella sentenza o “dichiarazione di morte” che sia Lyotard sia Vattimo avevano pronunciato nei confronti della Modernità e dei suoi “grandi racconti” o metanarrazioni. La perentoria presa d’atto della “fine del Moderno” investiva le figure, i codici e gli orizzonti che avevano segnato l’affermazione dell’epoca lungo tre secoli: per cui, adesso, venendo essa meno, trascinava con sé come detriti oramai consunti quei corollari e dispositivi che le avevano consentito di dispiegare la sua “metafisica influente”: il soggetto, la politica, lo Stato, l’idea di progresso, il senso della storia, il carattere futurizzante della temporalità.
Da quel momento, tra letteratura e filosofia, estetica e scienze umane, le forme di pensiero che si sono contese il campo sono state tutte attraversate –condividendo o respingendo “l’ideologia inconsapevole” di cui la condizione postmoderna si faceva portatrice– da quel dibattito, da quei problemi lungo assi culturali divergenti e spesso conflittuali. Se il postmoderno invitava a prendere atto dello scarto irreversibile apertosi tra esistenza e progetto, “spazio d’esperienza” e “orizzonte delle attese”, provando a giocare irenicamente la carta di un nichilismo compiuto –magari suggerendo una soggettività indebolita e “convalescente” protesa a godere l’esistenza nel clima di un progressivo addolcimento della condizioni di vita, sulle tracce di un Nietzsche e Heidegger “debolmente” interpretati da Vattimo–, il corpo a corpo che la “nuova condizione” sollecitava era tra chi intravedeva solo scenari apocalittici nel clima di “distruzione dell’esperienza” che la nuova fase portava con sé e chi provava a immaginare un “barlume di speranza” pur nello scenario nichilistico e omologante di un mondo resosi una immensa “società dello spettacolo”, secondo le profetiche intuizioni che Guy Debord veniva avanzando già sul finire degli anni ’60.
Ha come sfondo questa scena, questo panorama, il denso e bellissimo saggio di Georges Didi-Huberman, filosofo e raffinato storico dell’arte francese, i cui lavori, da alcuni anni, sono stati opportunamente pubblicati in italiano.
Il pretesto, o meglio, lo spunto iniziale del saggio, da cui Didi-Huberman dipana le sue argomentazioni, è il celebre “articolo sulle lucciole” di Pier Paolo Pasolini –nella versione dei suoi consueti editoriali pubblicati su “Corriere della Sera” l’articolo compariva, nel febbraio del ’75, col titolo emblematico “Il vuoto del potere in Italia”, mentre sarà riproposto nei suoi “Scritti corsari”, con il riferimento alle “lucciole”. Con tale espressione –suggestiva metafora del processo di un repentino “mutamento antropologico” che stava uniformando l’intera società italiana–, il poeta friulano provava a denunciare come la definitiva scomparsa delle lucciole dalle nostre strade, città e campagne costituiva la cifra del processo di estrema decadenza culturale e di consumata omologazione –una avvenuta sparizione dell’umanità–, che avvitavano oramai la società, resa spenta e priva di ogni capacità di “resistenza” di fronte alla luce accecante dei bagliori della società dello spettacolo.
«Le lucciole sono scomparse –commenta Didi-Huberman–, vale a dire: la stessa cultura, in cui Pasolini fino a quel momento riconosceva una pratica –popolare o d’avanguardia– di resistenza, è divenuta uno strumento della barbarie totalitaria, confinata, com’è oggi, nel regno della merce, della prostituzione, della tolleranza generalizzata» (p. 27).
Le amare e sconsolate riflessioni di Pasolini –“il popolo non c’è più”, “non c’è più spirito popolare”, “darei l’intera Montedison per una lucciola”– legano inestricabilmente gli aspetti estetici, politici e persino economici nel turbinio di un “vuoto di potere”, al cui interno “luccicano” –pertanto un finto splendore che ammutolisce e spegne definitivamente quelle intermittenze fosforescenti, come le lucciole, che con la loro leggerezza, i loro bagliori e movimenti sensuali ancora erano espressione di un barlume di speranza per un riscatto degli oppressi– la bolgia dei consiglieri fraudolenti, i lussuriosi, i violenti, i falsari: quasi una sorta di gironi danteschi che compongono un inferno realizzato. “L’Apocalisse –scrive Didi-Huberman– procede senza intoppi”.
Contestando il tono apocalittico e malinconico della lente pasoliniana, Didi-Huberman prova a sviluppare un serrato corpo a corpo con la tesi e la tonalità emotiva di Pasolini, lungo un itinerario che si snoda in modo impressionistico tra Walter Benjamin, Aby Warburg e Derrida. Per Pasolini, «le lucciole sono state vinte, annientate, trafitte da uno spillo o seccate dalla luce artificiale dei riflettori, dall’occhio panoptico delle telecamere di sorveglianza e dall’agitazione mortifera degli schermi televisivi…nelle società del controllo… non esistono più esseri umani, più nessuna comunità vivente…I barlumi sono scomparsi, insieme con l’innocenza condannata a morte» (p. 37).
Ma è proprio contro questo registro apocalittico e disperato, affiorante dalle amare riflessioni del poeta friulano, che Didi-Huberman rivolge i suoi strali, accomunando –per analogia– dentro la stessa orbita, un altro grande pensatore come Giorgio Agamben, al quale riconosce sì la straordinaria capacità di saper “inquietare il proprio tempo” offrendo nelle sue opere immagini e paradigmi –una vera e propria archeologia filosofica– che, fratturando il linguaggio, le apparenze e l’unità temporale delle cose, sanno mettere in luce le “sopravvivenze” del tempo arcaico che attraversano la stessa contemporaneità e la leggibilità del presente. Tuttavia, anche se Agamben –sulla scia di Benjamin e Warburg– sa cogliere e scavare dentro la genealogica potenza delle “immagini”, queste ultime gli appaiono, alla fine, eccessivamente “luminose”, col rischio di farle coincidere con «quell’orizzonte» in grado di prometterci “la grande luce lontana” (p. 53) e abbagliare così, in una sorta di deriva totalitaria e indifferenziata, quella “porta stretta” (Walter Benjamin) da cui può passare il Messia.
E proprio qui s’installa, come nei confronti di Pasolini, la critica di Didi-Huberman allo stesso Agamben –accomunati nel medesimo clinamen apocalittico–, oscillante tra la definitiva, già avvenuta “distruzione dell’esperienza” e, a un tempo, lo sguardo pur proteso a un orizzonte di “redenzione”, solo che tutto «…oramai [gli] appare solo come una pura funzione del potere, incapace del minimo contropotere, della minima insurrezione, della minima controgloria. Il che, ricordiamolo, indica molto più che una semplice questione di estetica: dallo statuto dell’immagine –dal valore d’uso che gli attribuiamo– dipende infatti l’apparizione della politica come tale, ciò che determina tutto il “valore di esposizione” dei popoli confrontati al “regno” e alla sua “gloria”» (p. 61).
E in questa citazione appare subito evidente il riferimento a una delle ultime fondamentali opere genealogiche di Agamben –Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo– nella quale la disperazione politica di Agamben sembra far velo alle sue pur straordinarie interpretazioni di Carl Schmitt, unificando e uniformando –sotto la medesima lente accecata e accecante di un totalitario “Regno glorioso”– «ottant’anni dopo di lui e nell’orizzonte della democrazia occidentale» (p. 61) un’immagine (certamente, sì, in parte consumata, e resa atona e anomica, come in effetti è il ruolo della “opinione pubblica” nel dominio della società dello spettacolo) a un orizzonte –quale è “l’acclamazione” del popolo davanti alla Gloria del “Regno” che fa dello “spettacolo” mitico-ideologico la forma per eccellenza con cui si rappresenta – e ci “rappresenta”– nella scena politica contemporanea.
Certo, sarebbe fuorviante e scorretto accostare la diagnosi che Agamben filtra dalla sua lettura della Dottrina della Costituzione di Carl Schmitt –su questa unificazione tra “immagine” (opinione pubblica) e “orizzonte” (acclamazione), le cui “differenze”, nella contemporanea società dello spettacolo rischiano di attenuarsi, riducendosi di molto– alle mire terapeutiche dell’autoritaria “democrazia identitaria” che il giurista di Plettenberg veniva formulando negli anni del nazismo. Resta il fatto che Agamben pone la questione –immagine/orizzonte– negli stessi «termini unilaterali –termini che non ammettono la minima controforma o il minino “controproblema”– e termina la sua indagine con il tono cupo, grigio acciaio, di una “coscienza infelice” condannata al proprio orizzonte, alla propria chiusura» (p. 63).
Se davvero, seguendo Schmitt, «l’opinione pubblica è la forma moderna dell’acclamazione» –certo, nel bagliore luccicante che il Regno glorioso pretende di farci vedere “sembra” che sia proprio così– allora non c’è spazio alcuno per “una politica delle sopravvivenze” (Didi-Huberman), e l’interdizione dell’agire, anche ed essenzialmente dello stesso agire politico, è ciò che ci rimane, nella disperazione di una “redenzione” divenuta davvero impossibile e di una “esperienza” definitivamente distrutta: non solo le lucciole sono definitivamente scomparse (Pasolini), ma anche lo spiraglio della “porta stretta” (Benjamin) si è chiuso oramai definitivamente alle nostre spalle. Una tonalità malinconica, apocalittica, sì, anche “pessimistica”. Ma così, tradiremmo proprio le istanze intermittenti che Walter Benjamin poneva nel suo Sul concetto di storia, quando scriveva, «organizzare il pessimismo vuol dire […] scoprire nello spazio dell’agire politico […] lo spazio delle immagini. Questo spazio però non si può assolutamente misurare in termini contemplativi […]. Questo spazio cercato è il mondo di attualità universale e integrale» (p. 498). Ecco, nella sua dimensione “metapolitica”, l’istanza di Benjamin di “organizzare il pessimismo” ha il sapore di chi sa che nel tempo presente noi mortali abitiamo una “radura”, al cui interno affiorano, dall’opacità e dal chiaroscuro, intermittenze luminose –immagini/lucciole– che aprono spiragli al mondo e alle nostre possibilità di riscatto. Sicché, l’esito finale propostoci da Didi-Huberman, in questo straordinario e suggestivo affresco della contemporaneità, sta nella nostra capacità di rifuggire dalla ricerca di “orizzonti”, “sta a noi non vedere scomparire le lucciole” (p. 92), sapendo cogliere le immagini intermittenti da cui balugina lo spazio di un agire, anche dello stesso agire politico.
| Georges Didi-Huberman |
| Come le lucciole. Una politica delle sopravvivenze |
| Bollati Boringhieri, |
| Torino, 2010 |
| Pagine 100 |
Nessun commento