Tornino i corpi. Considerazioni sulla vita dimidiata
Euristica della presbiopia
Sfuggente e asincrono è il funzionamento del linguaggio pubblico. Quando si parla di qualcosa vuol dire che non c’è ancora o non c’è già più; quando questo qualcosa si intronizza al centro della società e diventa preponderante si smette invece di vederlo e di pronunciarne il nome. Per far apparire il costrutto concettuale “dieta mediterranea”, ad esempio, si è dovuto aspettare che scomparisse o comunque che smettesse di essere la nostra ovvia alimentazione; quando Marcuse, a metà anni Sessanta, parlava dell’unidimensionalità della nostra epoca lo faceva in un tempo che visto dall’oggi (in cui di unidimensionalità non si parla) ci appare come un lussureggiante giardino temporale di mille varietà e mille diversità concettuali ed esistenziali. La presbiopia intellettuale, il non riuscire a vedere ciò che abbiamo vicino, è la regola dell’uomo e in fondo possiamo concepire la storiografia e la filosofia come le lenti di cui ci si è provvisti in questi secoli per stabilizzare la nostra visione e possiamo constatare come la loro fine odierna causi l’avvento di quella incomprensione tra il mondo e i suoi abitanti di cui in questi ultimissimi anni stiamo avendo un parossistico saggio.
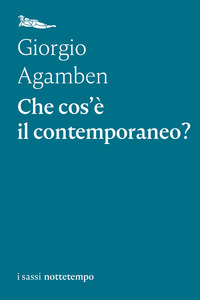 Non è del resto strano, a ben pensarci, che sia così: la contemporaneità, ci dice Agamben, la si vede solo a partire da uno slittamento, da una mancata coincidenza con essa. Non basta essere vivi in questo momento per essere contemporanei. Il filosofo, in quanto contemporaneo che vuole capire il proprio tempo e non limitarsi a viverlo, si trova costretto a stare un “po’ fuori” se vuole provare a scorgere qualcosa: guardare con attenzione ma tenendosi un passo indietro.1 Un lavoro improbo nell’era della perenne connessione, di quella accelerazione alienata di cui parla Hartmut Rosa.2 Però la filosofia, quando parla di sé, su questo sembra chiara. Dal destierro, l’esilio (reale e metaforico) di Maria Zambrano come unica dolorosa possibilità di capire il proprio paese, alla raccomandazione “ad assumere il colore dei morti” che ci giunge dalla grecità e che Hannah Arendt ci rimette davanti agli occhi, fino allo “stato di morte apparente” che Sloterdijk indica come condizione dell’esercizio filosofico.3 In questi come in altri passaggi la filosofia, come certi secondi all’angolo del ring, non fa altro che consigliarti di “tenere la distanza”. Lo fa in fondo fin dall’inizio della sua storia se si pensa che la tradizione (attraverso il Cicerone delle Tusculanae) ci consegna l’analogia di Pitagora, cioè di colui a cui si dovrebbe il termine stesso della disciplina, dei filosofi con gli spettatori dei giochi, cioè con coloro che nelle agitate giornate olimpiche nella polis, tra gente che gareggia, scommette, litiga, compra, vende, rimane ad osservare con attenzione ma sempre a una certa distanza.
Non è del resto strano, a ben pensarci, che sia così: la contemporaneità, ci dice Agamben, la si vede solo a partire da uno slittamento, da una mancata coincidenza con essa. Non basta essere vivi in questo momento per essere contemporanei. Il filosofo, in quanto contemporaneo che vuole capire il proprio tempo e non limitarsi a viverlo, si trova costretto a stare un “po’ fuori” se vuole provare a scorgere qualcosa: guardare con attenzione ma tenendosi un passo indietro.1 Un lavoro improbo nell’era della perenne connessione, di quella accelerazione alienata di cui parla Hartmut Rosa.2 Però la filosofia, quando parla di sé, su questo sembra chiara. Dal destierro, l’esilio (reale e metaforico) di Maria Zambrano come unica dolorosa possibilità di capire il proprio paese, alla raccomandazione “ad assumere il colore dei morti” che ci giunge dalla grecità e che Hannah Arendt ci rimette davanti agli occhi, fino allo “stato di morte apparente” che Sloterdijk indica come condizione dell’esercizio filosofico.3 In questi come in altri passaggi la filosofia, come certi secondi all’angolo del ring, non fa altro che consigliarti di “tenere la distanza”. Lo fa in fondo fin dall’inizio della sua storia se si pensa che la tradizione (attraverso il Cicerone delle Tusculanae) ci consegna l’analogia di Pitagora, cioè di colui a cui si dovrebbe il termine stesso della disciplina, dei filosofi con gli spettatori dei giochi, cioè con coloro che nelle agitate giornate olimpiche nella polis, tra gente che gareggia, scommette, litiga, compra, vende, rimane ad osservare con attenzione ma sempre a una certa distanza.
Se la distanza, l’estraneità come metodo di lavoro, la separazione come prerequisito professionale, rende l’incontro con il mondo non immediatamente fruibile (ma appunto solo mediatamente e questa mediazione necessaria è proprio la filosofia) e se ciò che abbiamo sempre sotto gli occhi scompare linguisticamente e invece ciò che scompare nell’esperienza riappare linguisticamente, è il caso di riflettere sulla costante dimenticanza del corpo da parte della filosofia. Per secoli, tra inviti funerei a pensarli come carceri o macchine abitate da fantasmi, i corpi, come ricordava Hans Jonas in una conferenza sul suo rapporto con la tradizione filosofica, sono i grandi assenti del pensiero occidentale.4. Quando lo scriveva, ormai anziano, Jonas si riferiva alla filosofia a cui si era formato nella Germania degli anni Venti del Novecento. Eppure oggi, un filosofo, riferendosi alla contemporaneità dopo Foucault, tra indagini fenomenologiche e riflessioni sull’ibridazione uomo macchina o sul rapporto tra sesso biologico e genere, avrebbe difficoltà a confermare quelle considerazioni che Jonas, quasi fossero scontate, offriva di passaggio.
La prospettiva d’indagine sopra abbozzata, potremmo dirla quasi un’euristica della presbiopia, ci porta a pensare che se i filosofi allora ne tacessero fosse perché il corpo, visto e pensato o meno, continuava ad esserci, a essere presente e persino preponderante, e se adesso ne parlano è perché il corpo, il nostro corpo, sta scomparendo. Il nostro parlare si sta facendo epigonale ed evocativo, ne parliamo perché il corpo siamo costretti a spiegarlo a noi stessi e a chi non sa più cosa sia. Con un perfetto colpo di rimbalzo Il delitto perfetto di Baudrillard si è mutato nel suicidio perfetto.5 Invece della scomparsa del mondo preconizzato da Baudrillard, a scomparire aiutati da altri strumenti e da altre vicende siamo stati noi. Invece di veder diventare simulacro e scomparire la realtà che ci si poneva davanti, è stato il nostro corpo a farsi diafano, irrilevante.
La guerra dei corpi
Ovviamente alla società fa gioco parlare del corpo come se esistesse ma, misconoscendolo, si ritrova a indicare qualcos’altro pensando di parlare di quello. Nella nota distinzione delle Meditazioni Cartesiane a cui si è usi rifarsi, Husserl scrive «Tra i corpi […] io trovo poi il mio corpo nella sua peculiarità unica, cioè come l’unico a non essere mero corpo fisico (Körper) ma proprio corpo organico (Leib)».6 Ebbene: questo ritrovamento si fa sempre più difficoltoso tanto da far pensare di essere sull’orlo di un cambiamento di paradigma, di una fase storica in cui convivono, non capendosi e spesso mal tollerandosi, gli appartenenti a due concezioni generali del corpo e quindi, di necessità, dell’umano. Se le incomprensioni, le insofferenze e le sofferenze si incontrano su questioni specifiche come è tipico di società poco filosofiche (esempio perfetto di questo biennio pandemico sono le polemiche sul distanziamento sociale e sulla possibilità della didattica a distanza di essere una valida alternativa a quella in presenza) sotto di esse il vero scontro è tra uomini che di fatto concepiscono il corpo secondo categorie radicalmente diverse.
 È dunque in corso un passaggio categoriale: per alcuni sono già scomparsi i corpi, il proprio e dunque anche quello degli altri. Alcuni di noi si collocano ancora in un primo paradigma (cronologicamente precedente) e altri in un secondo paradigma della cui progressiva vigenza non ci eravamo resi conto. Tra abitanti di questi diversi paradigmi possiamo trovarci d’accordo su alcune cose (quasi un falso positivo) ma il quadro concettuale e il modo di concepire la nostra stessa soggettività è talmente diverso che quando la ruota della storia torna, scricchiolando, a girare ci troviamo persino incapaci di capirci. Può essere la pandemia o altro, ma quando qualcosa di importante ci coinvolge, le basi diverse su cui costruiamo la nostra azione nel mondo decidono per noi da che parte dobbiamo stare.
È dunque in corso un passaggio categoriale: per alcuni sono già scomparsi i corpi, il proprio e dunque anche quello degli altri. Alcuni di noi si collocano ancora in un primo paradigma (cronologicamente precedente) e altri in un secondo paradigma della cui progressiva vigenza non ci eravamo resi conto. Tra abitanti di questi diversi paradigmi possiamo trovarci d’accordo su alcune cose (quasi un falso positivo) ma il quadro concettuale e il modo di concepire la nostra stessa soggettività è talmente diverso che quando la ruota della storia torna, scricchiolando, a girare ci troviamo persino incapaci di capirci. Può essere la pandemia o altro, ma quando qualcosa di importante ci coinvolge, le basi diverse su cui costruiamo la nostra azione nel mondo decidono per noi da che parte dobbiamo stare.
Il vecchio paradigma è quello in cui noi riteniamo di essere (anche) un corpo, quel corpomente su cui Biuso non a caso nei suoi recenti scritti sulla pandemia è più volte ritornato come centrale.7 Il Leib tedesco appunto, il corpo come centro di esperienza. Evidentemente ancora una volta l’euristica della presbiopia ci rassicura ma solo sul passato: per quanti dualismi e oggettivazioni si siano tentate nella storia del pensiero, la verità è che gli esseri umani hanno sempre pensato di essere un corpo più di quanto abbiano pensato di avere un corpo. Per questo essere amati per la propria bellezza (l’apparenza del corpo che siamo) lo abbiamo ritenuto non offensivo e spesso lusinghiero, mentre essere amati per i nostri soldi o in generale per ciò che abbiamo, lo abbiamo trovato offensivo.
Nel nuovo paradigma invece il corpo si pensa soltanto di averlo. È il Körper tedesco, in senso anatomo-fisiologico. Se il corpo è qualcosa che ho, evidentemente il vero io non sono il corpomente che sono, ma solo ciò che possiede il corpo: la mia mente. Si potrebbe far notare che questo “nuovo” paradigma sia in realtà il “vecchio” paradigma cartesiano e che nulla di nuovo vi è ma si passerebbe sopra qualcosa di enorme, cioè il fatto che questa ipotesi intellettualistica ora, per la prima volta nella storia, è possibile viverla esperienzialmente a livello di massa e le conseguenze tecnochiliastiche che ne derivano. Il sistema economico, tecnologico, consumistico, persino intellettuale e accademico ci chiede sempre più di essere solo mente, ci mette in lavori dove i corpi non solo non servono ma sono persino d’impaccio, ci fornisce divertimenti dove la presenza del corpo si riduce agli occhi e a due dita, ci ricorda il corpo non come portatore di istanze quanto come oggetto accessoriabile a pagamento con dei gadget.
Esercizi di sparizione
 Una serie di esercizi osservativi possono meglio farci distinguere lo scontro dei paradigmi. È il caso di svolgerli adesso perché il secondo paradigma guadagna terreno e a breve potrebbero essere necessari occhiali correttivi molto potenti per vederlo. Gli spunti sono molti e molti sono i fenomeni sociali che ci permettono di cogliere il corpo nell’epoca della sua sparizione. Ognuno di essi meriterebbe un saggio a sé, qui per questione di spazio ci limiteremmo a giustapporlo agli altri nelle sue linee di tendenza e di significato.
Una serie di esercizi osservativi possono meglio farci distinguere lo scontro dei paradigmi. È il caso di svolgerli adesso perché il secondo paradigma guadagna terreno e a breve potrebbero essere necessari occhiali correttivi molto potenti per vederlo. Gli spunti sono molti e molti sono i fenomeni sociali che ci permettono di cogliere il corpo nell’epoca della sua sparizione. Ognuno di essi meriterebbe un saggio a sé, qui per questione di spazio ci limiteremmo a giustapporlo agli altri nelle sue linee di tendenza e di significato.
Una riflessione sulla chirurgia plastica sui volti, in funzione di preteso ringiovanimento ma con effetto di modifica dei tratti del viso cos’è se non l’apoteosi del Körper? La mia faccia non sono io ma qualcosa che possiedo e devo renderla più adeguata al valore della gioventù come summum bonum. Se non sono riconoscibile agli amici (mi è capitato un paio di volte di non vedere riconosciute persone da conoscenti dopo gli interventi di “stiraggio e gonfiaggio”) o ai propri stessi occhi poco importa. Se il carrozziere mi ritocca l’automobile e riesce a farla sembrare il modello successivo perché mai dovrei lamentarmi? Sono forse io il mio volto? La risposta, per secoli, sarebbe stata: sì. Adesso per molti non è così immediato pensarlo.
Anni fa scrivevo della fine della boxe come segno dei tempi.8 Secondo uno dei più bei libri mai scritti su questa disciplina (che da sempre attira l’attenzione di scrittori e filosofi) cioè il saggio Sulla Boxe di Joyce Carol Oates, il pugile sarebbe caratterizzato dalla assoluta identità che riesce a stabilire con il proprio corpo. Sarebbe “più corpo degli altri” e lo sarebbe diventato attraverso la conoscenza piena del dolore e della fatica. La scomparsa della boxe e il ridimensionamento di altri sport basati sulla fatica (si pensi al ciclismo) come conoscenza di sé sono però metà della “cosa” che ci si para davanti; l’altra metà è la scomparsa in generale degli sport a fronte di un enorme numero di persone che muovono il corpo in palestra seguendo un generico fitness che fin dal linguaggio tradisce la ricerca dell’adeguatezza più che della prova con se stessi. Il fitness come disciplina fortemente estetica (intenta a fare in modo naturalistico quel percorso che altri fanno in modo chirurgico) e così scarsamente esperienziale abbisognava, per imporsi, di uno scivolamento verso il corpo oggettivato.
Anche il body shaming, la raccomandazione ad astenersi linguisticamente dal commentare il corpo altrui (a fini umoristici o meno) pur nella sua comprensibilità etica e nella bontà delle sue intenzioni si ritrova perfettamente sintonico con la scomparsa del corpo. Non commentare, fare finta di non notare il corpo brutto e in fondo anche il corpo bello (che farebbe risaltare il corpo brutto) accelera la scomparsa dei nostri corpi come protagonisti sociali e approssima l’epoca del corpo come mero bio-supporto delle menti.
Forse ancora più evidente il fenomeno si mostra nella scomparsa dello spazio della seduzione dei corpi nella cultura del politicamente corretto statunitense e nelle sue progressive metastasi europee. Fatto salvo il rifiuto della violenza e dell’aggressione nel rapporto tra i sessi con cui ogni persona civile non può che essere d’accordo, è interessante il modello sostitutivo “in positivo” che si propone e in parte già si attua. Un modello fatto di consensi informati, ostensibili, burocratici, che delimitino i successivi sviluppi sessuali di un incontro. Una invasione della contrattualistica negli aspetti più intimi degli esseri umani. L’evidenza massima di questo modello di conduzione dei rapporti interpersonali e seduttivi è l’eliminazione del linguaggio dei corpi e del loro peso. È prima che io devo già sapere cosa voglio e cosa posso fare. La mente a freddo decida e il corpo si limiti a eseguire. D’altra parte quando i corpi si fanno opachi ai nostri stessi occhi non è più possibile che si comunichi con essi e tra essi e la seduzione, come linguaggio dei corpi, di ciò che vogliono nel momento in cui lo vogliono, diventa un linguaggio che nessuno sa più parlare né capire. Costoro, i corpi, ciechi e sordi, non possono che affidarsi alla pattuizione para-giuridica o alla violenza.
Così confinata la sessualità, prestazione del corpo oggettivato sottoposta al controllo della performance tipico dei nostri tempi, essa diventa disagevole rispetto alla sessualità con simulacri (nelle varie forme che il web offre, divisibili tra esplicitamente autoreferenziali e fintamente intersoggettive) che si propone come prima scelta e come scelta più sicura.
La strada per la sessualità e cosa ancor più grave per l’eros, si ingrotta, attraverso il web e le applicazioni apposite, in un itinerario virtuale composto da valutazione reciproca dei soggetti adeguati, scelta, conoscenza, seduzione (quello straccio che ne resta) e perfino innamoramento posponendo l’incontro con i corpi (non con le immagini dei corpi fatti di pixel, va infatti ormai purtroppo segnalato che gli uni non sono gli altri) come coda faticosa socialmente e irta di pericoli e frustrazioni. Un passaggio, quello alla realtà dei corpi, che si fa sempre più faticoso e meno automatico.
Un filosofo mio amico celebrava le magnifiche sorti e progressive del web, che ben compensava a suo dire la reclusione sociale di questi anni, facendomi notare come grazie al web e alla sua espansione quasi totale nel sostituire eventi culturali e scientifici di questa fase pandemica, lui si era potuto permettere di partecipare a due esotici e lontanissimi convegni internazionali a cui per questioni logistiche ed economiche non avrebbe mai potuto partecipare. Lui, dunque, era convinto di aver davvero partecipato a un convegno in Australia restando nel suo appartamento, con moglie e figli nelle stanze accanto, davanti al suo computer. Aveva quindi trasformato l’esperienza di un convegno nell’esperienza dell’ascolto a distanza degli interventi congressuali. Un’esperienza piena esistenziale (si pensi alle idee di Illich sui congressi come meri pretesti per sviluppare amicizia e vero dialogo, cosa che ci dice avvenire solo fuori dai momenti ufficiali o si pensi, se vogliamo riderci su, ai romanzi di David Lodge sulle avventure congressuali) viene trasformata nel suo scheletro e solo poi ci si compiace di averla fatta. Il problema ovviamente, in questo caso nonché in generale, non è dato dai filosofi invecchiati male che “prendono per cielo il proprio computer” quanto dalla terrorizzante idea di assistere alla crescita delle future generazioni per cui i congressi saranno solo lo “scheletro del congresso” perché solo quello avranno conosciuto. Del resto avranno previamente già fatto la loro esperienza di semidigitalizzazione a scuola e avranno difficoltà a capire cosa manchi anche qualora venga loro spiegato.
 Si possono mettere tutti in fila i fenomeni sociali degli ultimi trent’anni. Porteranno tutti nel medesimo luogo: la trasformazione del corpo in un bio-supporto, da limitare progressivamente e aggirare dove possibile, posto a servizio della nostra mente (che così intesa è ovviamente una mera astrazione) che si costituisce come il nostro vero io. Tenendo fermo questo principio tutto si chiarisce, quello che abbiamo detto e quell’altro che potremmo ancora dire. Il tentativo di mettere sul binario morto i negozi fisici dove si ritrovano i nostri corpi a favore dei negozi telematici dove le nostre menti squadernano l’offerta infinita delle merci. L’idea di portare gli spettacoli ai nostri corpi immobili attraverso miriadi di piattaforme invece di spostarci insieme verso lo spettacolo. L’idea di “vivere” le cose occupandosi di registrarle per la mente futura con i nostri devices e non di esperirle pienamente con il corpomente di adesso. La sostituzione degli incontri in presenza con quelli in imago. L’esercizio del rapporto con gli altri, dell’amicizia e della conoscenza di persone nuove, dello scambio d’opinioni, in absentia attraverso chat et similia e non in presenza (con le ovvie conseguenze in termini di distruzione dell’empatia, delle relazioni e dell’intelligenza dialogica contemporanea di cui vediamo i frutti).
Si possono mettere tutti in fila i fenomeni sociali degli ultimi trent’anni. Porteranno tutti nel medesimo luogo: la trasformazione del corpo in un bio-supporto, da limitare progressivamente e aggirare dove possibile, posto a servizio della nostra mente (che così intesa è ovviamente una mera astrazione) che si costituisce come il nostro vero io. Tenendo fermo questo principio tutto si chiarisce, quello che abbiamo detto e quell’altro che potremmo ancora dire. Il tentativo di mettere sul binario morto i negozi fisici dove si ritrovano i nostri corpi a favore dei negozi telematici dove le nostre menti squadernano l’offerta infinita delle merci. L’idea di portare gli spettacoli ai nostri corpi immobili attraverso miriadi di piattaforme invece di spostarci insieme verso lo spettacolo. L’idea di “vivere” le cose occupandosi di registrarle per la mente futura con i nostri devices e non di esperirle pienamente con il corpomente di adesso. La sostituzione degli incontri in presenza con quelli in imago. L’esercizio del rapporto con gli altri, dell’amicizia e della conoscenza di persone nuove, dello scambio d’opinioni, in absentia attraverso chat et similia e non in presenza (con le ovvie conseguenze in termini di distruzione dell’empatia, delle relazioni e dell’intelligenza dialogica contemporanea di cui vediamo i frutti).
Solo a questo punto il transumanesimo, le suggestioni di immortalità di cui parla Mark O’Connel in Essere una macchina, tra teste ibernate e soteriologici download della nostra mente su silicio possono diventare persino verosimili e, cosa ancor più sorprendente, desiderabili.9 Se siamo solo mente, se siamo le stringhe di ragionamento logico che essa contiene, un disco rigido è il nostro adeguato paradiso.
Non è la produzione ideologica transumanista (ennesimo ritorno della gnosi) il vero problema quanto la sua propedeutica teurgia, questo esercizio antropotecnico di massa in grado di dimidiare gli umani in cui da qualche decennio siamo inseriti e da un biennio siamo prigionieri.
Note
1 G. Agamben, Che cos’è il contemporaneo, Nottetempo, Roma 2008, pp. 9-10. Per una proposta dello sguardo sulla contemporaneità come necessario “esercizio spirituale” mi permetto di rimandare al mio «La contemporaneità sospesa per un attimo. Note sulla condizione ipermoderna» in S. Charles, L’ipermoderno spiegato ai bambini. Lettere sulla fine del postmoderno, Bonanno, Acireale-Roma 2009.
2 H. Rosa, Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità, Einaudi, Torino 2015. In questo prezioso volumetto Rosa connette la sua ricerca alle condizioni di possibilità, in un’epoca di continua accelerazione, di poter vivere forme di Vita buona. Nel nostro caso possiamo interrogarci su un sottoinsieme della questione da lui non citato: la possibilità di vivere altresì forme di Vita filosofica. Come conciliare, infatti, la necessità del filosofo di restare discosto per poter vedere con un sistema che accelera perché è connesso ed è connesso per poter accelerare, con una società dove «l’accelerazione sociale è divenuta una forza totalitaria nella e della società moderna»? (H. Rosa, Accelerazione cit., p. 70).
3 cfr. M. Zambrano, I beati, Feltrinelli, Milano 1992, pp. 29-45; H. Arendt, La vita della mente, il Mulino, Bologna 1987, pp. 162-163 e P. Sloterdijk, Stato di morte apparente, Raffaello Cortina, Milano 2011.
4 H. Jonas, Scienza come esperienza personale. Autobiografia intellettuale, Morcelliana 1992, pp. 22-24.
5 J. Baudrillard, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà, Raffaello Cortina, Milano 1996.
6 E. Husserl, Meditazioni Cartesiane, Bompiani, Milano 1994, p. 119.
7 Si veda, tra gli altri suoi scritti, A.G. Biuso, Contro i negazionismi, in «Dialoghi Mediterranei» n. 47, gennaio-febbraio 2021, pp. 519-527.
8 Mi riferisco al saggio Estetica della boxe, apparso originariamente in Perelandra n. 1, 2001 e ora in D. Miccione, Ascetica da tavolo. La svolta pratica della filosofia e il bene comune, Diogene Multimedia, Bologna 2019.
9 Cfr. M. O’Connell, Essere una macchina, Adelphi, Milano 2018.
Nessun commento