Giovanni Verga
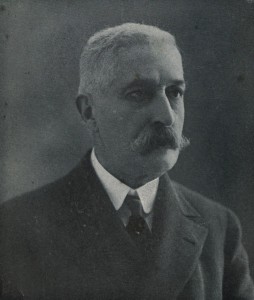 L’arcaismo, il caos, la potenza senza scopo della natura. Sono anche questi gli elementi che plasmano la Stimmung dei siciliani, i loro sentimenti, al tempo di Verga come nel nostro. In Verga essi si esprimono nella particolare tonalità di una razionalità positivistica che si coniuga all’assurdo metafisico, che osserva come «tutte le cose umane dànno una mano alla ragione e l’altra all’assurdo» (La cosa del diavolo, 15) 1, che «la verità…la verità…Non si può sapere la verità» (Il peccato di donna Santa, 697), sino a generare «uno sconforto amaro, un senso desolato del nulla d’ogni cosa umana, se non dura nemmeno il dolore» (Passato!, 770).
L’arcaismo, il caos, la potenza senza scopo della natura. Sono anche questi gli elementi che plasmano la Stimmung dei siciliani, i loro sentimenti, al tempo di Verga come nel nostro. In Verga essi si esprimono nella particolare tonalità di una razionalità positivistica che si coniuga all’assurdo metafisico, che osserva come «tutte le cose umane dànno una mano alla ragione e l’altra all’assurdo» (La cosa del diavolo, 15) 1, che «la verità…la verità…Non si può sapere la verità» (Il peccato di donna Santa, 697), sino a generare «uno sconforto amaro, un senso desolato del nulla d’ogni cosa umana, se non dura nemmeno il dolore» (Passato!, 770).
Dolore che intride le esistenze di tutti gli umani, qualunque sia la loro condizione di vita, di carattere, di situazione, di spazio, di tempo. Umani che sono intrinsecamente, inevitabilmente, «dolorosamente egoisti» (Frammento per Messina!, 799). Dolore che li rende consapevoli che la miglior sorte è morire, il non essere, «e se non fosse mai nato sarebbe stato meglio» (Rosso Malpelo, 168).
La ferocia dell’umano verso l’identità e il dolore degli altri animali (Storia dell’asino di san Giuseppe); la relazione di dipendenza che ogni affetto intrattiene con le condizioni economiche –«Il guaio è che non siamo ricchi, per volerci sempre bene» (Pane nero, 291)- poiché «Denari! tutto sta nei denari a questo mondo!» (In piazza della Scala, 338; Amore senza benda, 360); il profondo scetticismo sulla giustizia sia come ideale sia come pratica –«la Giustizia è fatta per quelli che hanno da spendere» (Don Licciu Papa, 230)– e la conseguente giustificazione del silenzio, dell’omertà, del chiudersi in se stessi.
Tutto questo è in realtà un universale antropologico che però assume una luce particolarmente vivida nella «maschera d’indifferenza orientale che è la dignità del contadino siciliano» (Jeli il pastore, 130), di questi enti fatti di terra, dalla terra nati come i guerrieri di Tebe nacquero dai denti del drago seminati da Cadmo. Esseri che non credono «né a Dio né al diavolo, sebbene li rispett[ino] entrambi» (Le storie del castello di Trezza, 67), che sono ben consapevoli – lo hanno sperimentato sulla propria carne, oltre che sull’anima – di quanto avidi e iniqui siano i religiosi della Chiesa romana, i loro frati e le monache, i loro ingordi e lussuriosi preti.
Enti costituiti dagli elementi primordiali del mondo: l’acqua del mare, la durezza della terra, la solitudine dell’aria, la potenza del fuoco. Quest’ultimo vince sempre nelle colate di lava che di tanto in tanto ricordano agli etnei la fragilità del loro stare: «Dal cortiletto davanti al palmento si vedeva la montagna nera che si accatastava intorno alla vigna, fumando, franando qua e là. Con un acciottolio come se si fracassasse un monte di stoviglie, spaccandosi per lasciar vedere il fuoco rosso che bolliva dentro» (I galantuomini, 308-309; anche Un’altra inondazione, 758).
A questi elementi ancestrali, mediterranei, arcaici appunto, si aggiungono le sciagure storiche che Verga descrive in modi che spesso ricordano Manzoni: il colera – il cui racconto è presente anche ne I Malavoglia –, la peste, l’andare dei soldati e il loro saccheggio delle terre. Con Manzoni lo scrittore condivide un altro elemento: Milano. Città da lui evidentemente amata, nella quale l’esistere e il destino della gente è doloroso e miserabile come quello dei contadini siciliani ma che però è uno spazio aperto al divenire rispetto all’immobilità dell’Isola: «Tutto ciò infine prova che Milano è la città più città d’Italia. […] Il più bel fiore di quella campagna ricca ma monotona è Milano; un prodotto in cui l’uomo ha fatto più della natura» (I dintorni di Milano, 765).
Ma sono di ambiente siciliano i romanzi e le novelle più grandi di Verga, quelli nei quali un asciutto e oggettivo dolore intride la parola, plasma l’immaginazione, condivide il pianto. Sentimenti intimi, personali, emotivi, la cui forza è singolare proprio perché scaturisce invece dall’intenzione di un’«opera d’arte [che] sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sorta spontanea come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo autore» (L’amante di Gramigna, 187). Capolavori della parola, del dolore e della storia sono Nedda, Rosso Malpelo, Il Reverendo, Libertà, L’ultima giornata, Un processo, Quelli del colera; novelle dalle quali non cito nulla perché soltanto una lettura integrale del tessuto narrativo unito al disincanto antropologico può restituirne il significato, l’emblema, la luce.
Sì, luce perché nella parola raccontata, nella parola che racconta, nel racconto che il mondo diventa dentro la parola emerge il grande amore, l’esclusivo amore che chi scrive nutre verso la scrittura, simile a «quella donna che gli aveva irradiato di luce la vita in un attimo, e che amava più della vita» (Le storie del castello di Trezza, 84).
Una novella merita più di ogni altra lo stupore che ogni capolavoro desta in chi vi s’accosti. Un racconto nel quale la dimensione epica che intesse tutta la narrativa di Giovanni Verga -i romanzi come le novelle– sembra raggrumarsi in poche e totali pagine. Racconto che inizia nello spazio sconfinato della terra: «Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell’ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristemente nell’immensa campagna…». Racconto che diventa cosmico, come in Alighieri, come in Leopardi, come in ogni altro narratore che attinga la profondità degli enti e degli eventi: «Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell’assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra» (256-257). Si intitola, naturalmente, La roba questo racconto. La roba è parola tra i siciliani sacra tanto più quanto il rapporto con gli averi, con la fatica necessaria a ottenere roba e averi, descrive la malasorte, nel primo romanzo, di un uomo – padron ‘Ntoni –, di una famiglia – i Toscano/Malavoglia -, di un paese – Acitrezza -, di un popolo – i meridionali -, dell’umanità – i vinti e i deboli di ogni tempo e luogo, i quali «levano le braccia disperate»2.
Ma il romanzo nel quale l’epica fa tutt’uno con lo stile, la tenacia con la sconfitta, il progetto con il nulla è Mastro-don Gesualdo, capolavoro assoluto dell’antropologia letteraria. Un’umanità famelica, miserabile, buia viene scandita da un narrare limpido, lancinante, ironico e oggettivo. La vita di Gesualdo Motta si fa metafora del mondo, della vita, dell’essere tutti contro tutti dentro una società rurale, rassegnata e colma di rancore; scossa di tanto in tanto dall’illusione di un’impossibile giustizia. Si squaderna davanti a noi l’Isola di tripudi e di sfacelo, intrisa di segreta magia e di quotidiana fatica. Mastro-don Gesualdo è un romanzo ancestrale, una sintesi della Sicilia, delle sue maledizioni, della grandezza. «Sempre in moto, sempre affaticato, sempre in piedi, di qua e di là. Al vento, al sole, alla pioggia; colla testa grave di pensieri, il cuore grosso d’inquietudini, le ossa rotte di stanchezza»3, Gesualdo è la solitudine stessa. Dei siciliani, certo, ma anche di ogni umano che non si voglia ingannare sulla propria condizione. «Col cuore grosso dell’ingratitudine che raccoglieva sempre», dinanzi alla morte che un tumore allo stomaco – naturalmente psicosomatico, come lui stesso intuisce – gli prepara, «avrebbe voluto distruggere d’un colpo tutto quel ben di Dio che aveva accumulato a poco a poco. Voleva che la sua roba se ne andasse con lui, disperata come lui»4. Nell’implacabile epica del mondo, della sua fatica, della morte, Mazzarò e Gesualdo sono naturalmente la stessa persona, la persona umana, fatta di gaudio inquieto, di prestazione, di possesso, di ferocia: «Roba mia, vientene con me!» (La roba, 262).
Note
1 G. Verga, Tutte le novelle, a cura di G. Zaccaria, Einaudi, Torino 2015. Le citazioni da questo volume saranno indicate con il titolo della novella e il numero di pagina.
2 Id., I Malavoglia, Mondadori, Milano 1976, p. 52.
3 Id., Mastro–don Gesualdo, Mondadori, Milano 1963, p. 78.
4 Ivi, pp. 260 e 347.
Nessun commento