«Barocco è il mondo»
Un compiuto disvelamento del reale, una delle più radicali esperienze di scrittura del Novecento, il mondo che si fa parola. Anche questo è l’opera di Carlo Emilio Gadda (1893-1973)1.
Il Pasticciaccio
Di quest’opera il Pasticciaccio è soltanto una delle espressioni, per quanto straordinarie siano la complessità stilistica e la meditazione sui temi del vivere e del morire, della razionalità e della follia che intesse gli eventi. L’uso magistrale dei più disparati strumenti linguistici e stilistici perviene a una scrittura stratificata, ingarbugliata, lirica. Una scrittura attraverso la quale transita l’efferato enigma del reale, proprio mentre sembra che vi sia descritta la più risaputa quotidianità. La «debilitata “ragione del mondo”» (Q 3) indaga nelle pieghe più riposte degli eventi e degli umani, pervenendo in ultimo a dispiegare in tutta la sua rissosa stupidità «la insospettata ferocia delle cose» (Q 70).
Nel Pasticciaccio la morte appare quasi subito nella gola squarciata di Liliana, va poi lentamente e ripetutamente modulandosi come «gelo che d’ogni memoria ci assolve» (Q 71), come -quasi heideggerianamente- «decomposizione estrema dei possibili» (Q 73), illimitato «mare d’ombra» e «ignota libertà del non essere, gli evi liberi» (Q 335 e 121). Il male sembra consistere nel «ridestarsi a conoscere: a riconoscere e a rivivere la verità d’ogni giorno» (Q 326). Il male è l’inevitabile e sommerso procedere alla morte. L’ironico furore e la rassegnazione amara di chi sa di vivere «nell’arena bestiale della terra» (Q 203) vengono tuttavia trasfigurati in una partecipe meditazione sui destini dolorosi dell’esserci.
Milano
La Roma del Pasticciaccio è un luogo linguistico, come lo è la Milano «città egèmone», con il suo antico simbolo della «proliferante scrofa, animale dilettissimo all’Autore» (A 171 e 193). Le città e gli spazi costituiscono il luogo sociale e psichico nel quale accadono gli eventi quotidiani che Gadda sa trasformare in un epos di stupefacente, galoppante, frenetica invenzione linguistica, in una dolente osservazione del cosmo umano, in una fenomenologia dei gesti, degli eventi e delle cose che si esprime in molteplici forme: nello sterminato elenco degli oggetti; nella miseria del pettegolezzo attuato da chi “senza né figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto” come canta De André; nello smascheramento della macabra ipocrisia dei necrologi. Dal quotidiano alla grande storia non c’è salto: una magnifica pagina ricostruisce la vita di Napoleone Bonaparte «intrigante arrivista […] incoronando prepotentello» immerso nella «dorata e smaltata chincaglieria ed aquileria cesarea» (A 51-56).
L’affettuosa e insieme severa descrizione della vita milanese agli inizi del Novecento diventa una riflessione sulla «folla tediosa dei viventi» (A 233), segnata dal limite costitutivo per il quale «ogni più nobile schema nella imperfettibilità del mondo si avvera e perfeziona cariandosi, cioè accompagnandosi di qualche inevitabile imperfezione. Così come il corpo, andando, si accompagna del peso (gravame): e talora di un’ombra» (A 136). Il male, la morte e l’oltraggio -che della morte è figura- disegnano la potenza del tempo, costruiscono la vita come forma malinconica della memoria, di quanto ottenuto, del molto smarrito.
Storia, tempo, ironia
Nei tanti suoi racconti variamente pensati, composti e pubblicati, Gadda rivela dunque la banalità, l’ipocrisia e l’orrore. E anche nel diario che l’ingegnere scrisse sul fronte della Prima Guerra Mondiale e durante la prigionia in Germania scorrono la pietà e la vergogna per le condizioni dei compagni nelle trincee, la lucida percezione del tradimento che l’Italia perpetrava nei confronti di tante persone mandate a morire, il rapporto profondo con il fratello Enrico ucciso in battaglia, la fatica del ritorno in una patria nella quale le speranze di grandezza e di rinnovamento vennero tutte tradite. Tradite soprattutto dal fascismo, dal “Bombetta, Cuce, Mascelluto narcissico” nel quale si condensa la farsesca ferocia del Potere, dell’Io mortale che si crede privo di limiti:
Il folle narcissico (o la folle) è incapace di analisi psicologica, non arriva mai a conoscere gli altri: né i suoi, né i nemici, né gli alleati. Perché? Perché la pietra del paragone critico, in lui (o in lei), è esclusivamente una smodata autolubido. Tutto viene relato alla erezione perpetua e alla prurigine erubescente dell’Io-minchia, invaghito, affocato, affogato di sé medesimo. […]
Seconda caratterizzazione aberrante, e analoga alla prima, anzi figliata da lei, è la loro incapacità alla costruzione etica e giuridica: poiché tutto l’ethos si ha da ridurre alla salvaguardia della loro persona, che è persona scenica e non persona gnostica ed etica […] Tutto il lavoro, tutta la fatica, tutta la speranza, tutto il sogno, tutto il dolore umano sono a culminare nella loro vanità mal protesa, a turibolare il loro glande di porfido, porfidescamente incretinito. Lo jus, per loro, è il turibolo: religio è l’adorazione della loro persona scenica; atto lecito è unicamente l’idolatria patita ed esercitata nei loro confronti; crimine è la mancata idolatria.
[…]
Men che meno il narcissico può esser filosafo, o costituirsi discepolo di filosafi alla scuola d’Atene […] Il costruire sistemi filosofici sulla propria indole ghiandolare, cioè aventi la propria tiroide o le surrenali a meccanismo impulsore del mondo, il suo costituire il proprio bellìco a perno del mondo, a pivot, non è operazione filosofica.
[…]
L’autofoja, che è l’ismodato culto della propria facciazza, gli induce a credere, per poco che quattro scalmanati assentano, gli induce a credere d’esser daddovero necessarî e predestinati da Dio alla costituzione e preservazione della società, e che senza loro la palla del mondo l’abbi a rotolare in abisso, nella Abyssos primigenia: mentre è vero precisamente il contrario: e cioè che senza loro la palla de i’ mondo la rotola come al biliardo e che Dio esprime in loro il male dialetticamente residuato dalle deficitarie operazioni collettive, dalla non-soluzione dei problemi collettivi: essi sono il residuato male defecato della storia, lo sterco del mondo.
[…]
Sul palco, sul podio, la maschera dello ultraistrione e del mimo, la falsa drammaticità de’ ragli in scena, i tacchi tripli da far eccellere la su’ naneria: e nient’altro.
(Ep, pp. 143-156)
Questa scrittura folgorante e annichilente svela l’infinita volgarità dei Bombetta di ieri, di oggi, di sempre. La guerra è l’insensata disperazione con la quale gli umani e la storia si puniscono del fatto d’esserci. La morale -la sua stessa possibilità- è una finzione. L’idolatria verso l’infanzia è strumentale bisogno di non morire. Il tempo è «lieve suasore d’ogni rinuncia» (Ac 162). Il tempo. Un lampo proustiano sembra insinuarsi e splendere in pagine materiche, dolorose e raffinate: «Terra vestita d’agosto, v’erano sparsi i nomi, i paesi» (Ac 141); proustiano è anche l’erotismo alto e profondo di alcuni racconti, come Cugino barbiere, La sposa di campagna e il molto amato dall’Autore San Giorgio in casa Brocchi.
L’ironia fa da costante contrappunto -armonioso e dissonante insieme- al tentativo di dire l’indicibile: «…come d’una stele infranta si disperdono smemorate sillabe, e già furono luce della conoscenza, e adesso l’orrore della notte» (Ac 166). Due dei racconti più intensi sono quelli da cui ho citato sinora –Una visita medica, La mamma– entrambi estrapolati da La cognizione del dolore, vero motore e sorgiva del narrare di Gadda, teso a descrivere «nella vacuità degli spazi senza senso l’ellisse del nostro disperato dolore» (Ac 156) sino a racchiudere in una terribile icasi l’enigma: «Non vide più nulla. Tutto fu orrore, odio» (Ac, 158).
La versione divertita di tale orrore è un racconto capolavoro, quell’Incendio di via Keplero tutto movimento, velocità, fiamme davvero: «Se ne raccontavano di cotte e di crude sul fuoco del numero 14. Ma la verità è che neppur Sua Eccellenza Filippo Tommaso Marinetti avrebbe potuto simultanare quel che accadde, in tre minuti, dentro la ululante topaia, come subito invece gli riuscì fatto al fuoco: che ne disprigionò fuori a un tratto tutte le donne che ci abitavano seminude nel ferragosto e la lor prole globale…» (Ac 109).
Senza pietà, senza pietà -e dunque con verità- a descrivere l’oscenità dell’umano, della «miseranda gallinazza […] senz’uomo a fianco e senza farmaco a lato» (Ac, 203) alla quale «i medici più costosi della città le avevano detto ch’era schizofrenica: altri, non medici, ch’era un’oca» (Ac, 243). Tutti: commendatori, filosofi, ragazze, pappagalli, poeti, ingegneri, bottegai, nobildonne, domestiche, soldati, bambini, operai, studenti, tutti destinati dall’esser nati a «chiuder gli occhi nel sonno della morte men duro, se pur duro, dacché più o meno duro ma pur duro e durissimo ce l’hanno tutti, il sonno, allorché si tratti di quella bella pennichella dentro l’urna» (Ac, 326), come con antifoscoliana veemenza Gadda ironicamente canta.
Conoscere il dolore
Un canto che si dispiega più che in ogni altra sua opera nell’incompiuto La cognizione del dolore, grottesco e tragico itinerario nelle tenebre. In esso nulla succede se non il finale assassinio. Per il resto vi si descrive la vita nelle ville, villette, villoni del Maradagal-Serruchòn, in un improbabile Sudamerica che è la Brianza. La vita, in particolare, del marchese Gonzalo Pirobutirro e della sua vecchia madre. In queste due figure, in modo diverso ma integrale, si condensano tutta l’innocenza e tutto il dolore del mondo.
Gonzalo legge Platone e vorrebbe vivere di solitudine e di silenzio. La madre invece -figura di perenne lutto dopo la morte in guerra dell’altro figlio- gli riempie la vita e la villa di contadini e donnette tanto puzzolenti quanto rapaci. Il conflitto è fra una consapevolezza del mondo lucida sino alla disperazione -«egli era un uomo […] di criterio piuttosto forte e, direi, temperato. Nessuna illusione» (C 168)- e una bontà ancor più disperata, complice involontaria dei malvagi e degli sciocchi, permeata di un cristianesimo sin troppo facile, troppo condiscendente, vile.
Nel segno di Manzoni -e certo anche molto al di là di lui- da tutto il romanzo si sprigiona un’immensa forza etica e antropologica, un rigore morale sconosciuto a un paese facile e cattolico. Gonzalo «non aveva nessun genio per l’arrabattarsi e il tirare a campare. E c’era, per lui, il problema del male» (C 45); «Aveva, della legge, un concetto sui generis […] consustanziato nell’essere, biologicamente ereditario» (C 88). Questo libro sa mostrare il cuore della corruzione, del cattivo gusto, della mala educazione; a Gadda sono estranei lo storicismo che tutto assolve, la fiducia ebete in un progresso senza fine, il culto del meglio identificato con ciò che è nuovo e vincente. C’è invece la consapevolezza «della scemenza del mondo o della bamboccesca inanità della cosiddetta storia, che meglio potrebbe chiamarsi una farsa da commedianti nati cretini e diplomati somari» (C Appendice, 199). Ciascuno diventa quello che è, ciò che la casualità genetica della materia lo ha fatto, rendendo a sua volta inane l’illusione d’educare uomini:
si incontrano dunque, talora, individui ben nati, e relativamente ben vissuti, negli ambienti pedagogicamente più tristi: dacché resistenze insapute vigono e valgono in loro per una sorta di eredità (ignorata dall’erede) contro l’istanza sovvertitrice degli esempi. Si vedono tal’altra volta, per contro, riuscir a male ragazzi “amorosamente” cioè pignolosamente educati, quando il crostone della retorica moralistica di superficie, il caramello etico rovesciato a parole sulla loro fralezza cremosa, non è valso a ricomporre, in un’anima che va in pezzi, lo spirito e le ragioni della vita: cioè la brama di conquista biologica, di ascensione, di profittevole scelta, di accumulo. Dopo rotto il déclic della molla organica interna, non c’è diti di Vescovo né virtù ed unzione di Sacramento che valga a rimontarne il tic-tac.
Il gioco multiplo e avaro degli infinitesimi, delle minime elezioni accumulatrici, della dura disciplina selettrice, s’è scombinato in un blando desiderio di requie, s’è rilassato in un abbandono (alla lubido), o ne’ pisoli della vanità soddisfatta, s’è sdraiato in una eutanasia: l’essere è, da dentro, un morente: per cui la tromba la può suonare a perdifiato, ma suona invano. (A 280)
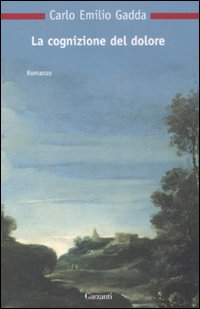 Gadda sa che il Tempo è anche divoratore di speranza, che sofferenza e tenebra avvolgono le cose, gli uomini, il vivente nella corsa magnifica e insensata degli evi. Ma egli vuole conoscere il dolore, averne cognizione. Nell’ironia parossistica e nel grottesco riemerge la gnosi profonda, il disprezzo verso la folla e l’umano, l’orrore e l’ambiguo fascino della materia, della voluttà, del corpo. L’umanità, «questo mare senza requie, fuori, sciabordava contro l’approdo di demenza, si abbatteva alle dementi riviere offrendo la sua perenne schiuma, ribevendosi la sua turpe risacca» (C 131). Uomini e donne, furbi e sciocchi, ragazzi e vecchie «venuti fuori anche loro dall’Arca bastarda delle generazioni» (C 132) sono la folla turpe e feroce che distrugge, con la sua sola esistenza, il poco di bellezza delle cose, sono quella «moltitudine pazza» la quale -«Megera anguicrinita» (Q 104)- si riscatta soltanto quando il collettivo diventa l’individuale miseria -cenciosa e oppressa- dei poveri e degli umili, la cui stentata fatica è guardata con pietà. Il disprezzo di Gadda per il fascismo deriva anche dalla menzogna mussoliniana che seduce le masse e insieme adula «la mattana collettiva» (Q 104).
Gadda sa che il Tempo è anche divoratore di speranza, che sofferenza e tenebra avvolgono le cose, gli uomini, il vivente nella corsa magnifica e insensata degli evi. Ma egli vuole conoscere il dolore, averne cognizione. Nell’ironia parossistica e nel grottesco riemerge la gnosi profonda, il disprezzo verso la folla e l’umano, l’orrore e l’ambiguo fascino della materia, della voluttà, del corpo. L’umanità, «questo mare senza requie, fuori, sciabordava contro l’approdo di demenza, si abbatteva alle dementi riviere offrendo la sua perenne schiuma, ribevendosi la sua turpe risacca» (C 131). Uomini e donne, furbi e sciocchi, ragazzi e vecchie «venuti fuori anche loro dall’Arca bastarda delle generazioni» (C 132) sono la folla turpe e feroce che distrugge, con la sua sola esistenza, il poco di bellezza delle cose, sono quella «moltitudine pazza» la quale -«Megera anguicrinita» (Q 104)- si riscatta soltanto quando il collettivo diventa l’individuale miseria -cenciosa e oppressa- dei poveri e degli umili, la cui stentata fatica è guardata con pietà. Il disprezzo di Gadda per il fascismo deriva anche dalla menzogna mussoliniana che seduce le masse e insieme adula «la mattana collettiva» (Q 104).
Nell’evidenza dell’arte e nell’efficacia della parola splende la becera assurdità di una democrazia cieca, incapace di percepire la differenza fra il lettore di Platone e il peone furbastro, una democrazia quindi prodiga nell’offrire a entrambi un eguale diritto di voto (C 200). La pietà di Gadda è invece rivolta agli onesti, al «ragazzo vivo e normale» al quale una concezione distorta della solidarietà preferisce i «più snaturati delinquenti» (C 201); è rivolta a chi chiede a se stesso rigore; è rivolta ai più forti, ai puri, che sempre bisognerà difendere dai più deboli quando i deboli -come sempre accade- sono legione.
La poesia di Gadda canta la gloria di un mondo barocco ma solo perché il grottesco e il barocco risiedono già nelle cose. E quindi il luogo comune che quasi imputa a Gadda il suo esser barocco «potrebbe commutarsi nel più ragionevole e più pacato asserto “barocco è il mondo, e il G. ne ha percepito e ritratto la baroccaggine”» (C Appendice, 198).
Emblematica di tanto fastoso dolore è questa pagina:
Camminava tra i vivi. Andava i cammini degli uomini. Il primo suo figlio […] in una lunga e immedicabile oscurazione di tutto l’essere, nella fatica della mente, e dei visceri dischiusi poi al disdoro lento dei parti, nello scherno dei negoziatori sagaci e dei mercanti, sotto la strizione dei doveri ch’essi impongono, così nobilmente solleciti delle comuni fortune, alla pena e alla miseria degli onesti. Ed era ora il figlio: il solo. Andava le strade arse lungo il fuggire degli olmi, dopo la polvere verso le sere ed i treni. Il suo figlio primo. […] Il suo figlio: Gonzalo. A Gonzalo, no, no!, non erano stati tributati i funebri onori delle ombre; la madre inorridiva al ricordo: via, via!, dall’inane funerale le nenie, i pianti turpi, le querimonie: ceri, per lui, non eran scemati d’altezza tra i piloni della nave fredda e le arche dei secoli-tenebra. Quando il canto d’abisso, tra i ceri, chiama i sacrificati, perché scendano, scendano, dentro il fasto verminoso dell’eternità (C 116)
L’unicità di Gadda, il maggiore insieme a Elsa Morante dei narratori italiani del Novecento, consiste anche nella sua assenza di retorica, in un Paese e in una letteratura che troppo la conoscono. Nessun romanticismo, né estetico né esistenziale. L’espressionismo è indice anche di questo rifiuto di un io strabordante e narciso al quale Gadda sostituisce il rigore di una oggettività barocca, spietata eppure colma d’amore.
I testi di Gadda vengono citati con le sigle qui indicate, seguite dal numero di pagina:
A
L’Adalgisa – Disegni milanesi (1943)
Nota al testo di Guido Lucchini
Garzanti 2007 – «Gli elefanti»
Pagine 297
Q
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957)
Garzanti 1983 – «I grandi libri»
Pagine XX-343
C
La cognizione del dolore (1963)
Garzanti 1994 – «Narratori moderni»
Pagine 213
Ac
Accoppiamenti giudiziosi (1963)
Presentazione di Gianfranco Contini
Nota di Raffaella Rodondi
Garzanti 2001 – «Gli elefanti»
Pagine 343
Ep
Eros e Priapo (1967)
Introduzione di Leone Piccioni
Garzanti 2007 – «Gli elefanti»
Pagine 175

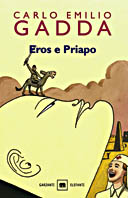
Nessun commento