Vulnerabilità, cura, limite
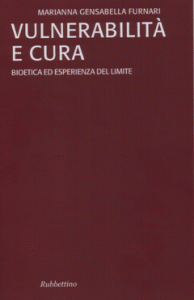 Rispetto all’ampiezza della bibliografia presente, alla presenza nel dibattito culturale e politico, al peso posseduto in decisioni che influenzano fortemente la nostra quotidianità, la bioetica sembra a volte esprimersi attraverso una letteratura ripetitiva, poco incisiva, scolastica. Quest’ultimo aggettivo in entrambi i significati: quello del linguaggio comune e quello più filosofico. Scolastico, dunque nel senso di manualistico. Grande è la produzione, né accenna a esaurirsi, di manuali, compendi, istituzioni. Il rischio è, niccianamente, che il morto uccida il vivo, che si trasformi una disciplina che vive l’esperienza drammatica dello spostamento continuo dei limiti operato della tecnologia in una cattedrale di concetti rigidamente e gerarchicamente ordinati. Ciascuno può immaginare quanto questa immagine possa accordarsi con quella di un uomo che vive nella consapevolezza della mutevolezza e della diversità delle situazioni in cui la domanda etica urgentemente si pone. Scolastico però anche nel senso di sussistente esclusivamente all’interno di un dibattito, di un linguaggio, di riferimenti sempre più interni al dibattito stesso, di questioni sempre più minute e specialistiche.
Rispetto all’ampiezza della bibliografia presente, alla presenza nel dibattito culturale e politico, al peso posseduto in decisioni che influenzano fortemente la nostra quotidianità, la bioetica sembra a volte esprimersi attraverso una letteratura ripetitiva, poco incisiva, scolastica. Quest’ultimo aggettivo in entrambi i significati: quello del linguaggio comune e quello più filosofico. Scolastico, dunque nel senso di manualistico. Grande è la produzione, né accenna a esaurirsi, di manuali, compendi, istituzioni. Il rischio è, niccianamente, che il morto uccida il vivo, che si trasformi una disciplina che vive l’esperienza drammatica dello spostamento continuo dei limiti operato della tecnologia in una cattedrale di concetti rigidamente e gerarchicamente ordinati. Ciascuno può immaginare quanto questa immagine possa accordarsi con quella di un uomo che vive nella consapevolezza della mutevolezza e della diversità delle situazioni in cui la domanda etica urgentemente si pone. Scolastico però anche nel senso di sussistente esclusivamente all’interno di un dibattito, di un linguaggio, di riferimenti sempre più interni al dibattito stesso, di questioni sempre più minute e specialistiche.
Insomma, a mio parere il rischio è che non solo l’uomo colto ma addirittura lo studioso o l’appassionato di filosofia vengano respinti dall’ancipite volto del trattato istituzionale e della quaestio specifica (l’embrione, la fecondazione omologa ed eterologa ecc.). Se ciò avvenisse la bioetica rischierebbe di vedere a monte prosciugata la sua fonte primigenia (la filosofia tout court) e a valle bloccata la sua foce naturale (la capacità di parlare a tutti ma anche la capacità di informare e formare le élites). Una piena consapevolezza di questi rischi mi pare emerga nel volume che qui ci troviamo a commentare: Vulnerabilità e cura. Bioetica ed esperienza del limite, uscito per i tipi della Rubbettino a firma di Marianna Gensabella Furnari, membro del Comitato nazionale di bioetica e docente di Filosofia morale all’Università di Messina.
Una piena consapevolezza condivisa anche dal prefatore, quel Warren T. Reich autore o curatore di monumentali lavori sul concetto di cura, che proprio nella prefazione a questo volume lamenta l’eccessivo concentrarsi della produzione editoriale bioetica intorno a «due tipologie: opere di carattere generale che hanno la funzione di libri di testo, e volumi che si occupano di un singolo argomento» (Prefazione, p. 7). Vulnerabilità e cura prova invece a sfuggire (a mio parere con pieno successo) a questi due rischi. Esso fortunatamente ancora pretende di parlare ai filosofi nel senso più ampio del termine.
Certo, la Gensabella Furnari è autrice collocata in posizione centrale nel dibattito bioetico (si pensi solo alla mole di lavoro, tra scrittura, coordinamento e stimolo, sul tema dell’eutanasia e più in generale del morire) e conosce perfettamente dunque la natura ibrida della disciplina, il suo dover interagire con campi di studio estranei al pensare filosofico e provvisti di griglie epistemologiche del tutto diverse; conosce altresì la natura di una disciplina «in cui occorre dare risposte. Lo voglia o no, è questo che il bioeticista è chiamato a fare» (p. 11). Sa anche però che questa natura di confine e questo essere continuamente tirati per la manica da una società che vuole risposte più che problematizzazioni (si pensi alla rozzezza con cui la politica si è impossessata dell’enormi questioni sottintese al caso Englaro) proprio perché non può essere negata deve generare una maggiore attenzione nel mantenimento dell’ampiezza filosofica con cui ci si deve avvicinare a certi temi.
L’ampiezza di cui parliamo non è il lavoro fatto ad alti livelli di astrazione e generalità, ma il lavoro di ripensamento ed allargamento delle questioni che è tipico del filosofo. La questione informa certamente il rapporto della Gensabella con “l’etica dei principi” e la “bioetica dei principi”. L’approccio principiale, che relega le situazioni concrete a mero contenitore di decisioni e norme altrove costruite, viene qui colto nei suoi limiti: «dalle premesse di fondo dell’etica si traggono i princìpi, dai princìpi le norme, da queste i giudizi morali con cui risolvere i “casi”» (p. 16). A esso l’autrice sembra affiancare (proponendo una compenetrazione più che una sostituzione dell’uno all’altro) un’etica della cura. Da qui la costruzione di un itinerario assai affascinante che vede nei lavori del femminismo della differenza, in particolare nel lavoro sulla costruzione di un’etica di genere di Carol Gilligan, la matrice di un etica della cura. La proposta della Gilligan, di affiancare all’etica della norma un’etica che faccia perno sulla situazione e sulla relazione, appunto un’etica della cura, ancorandola al femminile, vien colta con ampiezza teoretica dalla Gensabella. In questo senso la voce differente di cui parla Gilligan non sarebbe la costruzione di un “lettura di genere” (nulla di più lontano dall’autrice che voler costruire una bioetica di genere) quanto l’opportunità fornita dalle (e alle) donne di poter cogliere il valore della cura e proporlo in quelle letture della realtà che palesemente lo sconoscono: «si tratta delle voci delle donne, ma non solo: sono le voci di soggetti deboli, che stentano a farsi sentire, proprio per la loro debolezza: le voci di coloro che soffrono, le voci delle minoranze» (p. 21).
La donna, insomma, per biologia o storia o semplice collocazione sociale (ai fini del discorso la questione si fa poco rilevante) potrebbe meglio cogliere il valore della cura e la voce degli esclusi che è sottesa a questi valori. La lettura di genere diventa dunque la possibilità di ripensare il ruolo delle voci più deboli, appartate, ghettizzate e su di esse provare a ricostruire una lettura del mondo e dell’etica meno squilibrata. La cura in questo senso apre ad altri principi fondamentali a cui l’autrice (quando ritiene di dover dialogare con chi permane nel paradigma principiale) richiama vedendoli come fondamentali per allargare l’angustia di certe visioni. Tra questi spicca la riflessione sulla persona, sull’uomo come mezzo e fine, attraverso una lettura delle posizioni di Kant, Mill e Singer; spicca inoltre proprio quel principio di vulnerabilità che dà il titolo al volume. Spicca dunque la centralità di questo dato che palesemente richiama alla cura, cioè il fatto di essere tutti gli umani vulnerabili, nei sensi e nei modi più vari. Giustamente annota l’autrice: «portare a principio la vulnerabilità significa riportare dentro ciò che il principio di autonomia lasciava fuori: la debolezza evidente dei soggetti non-autonomi, ma anche il fondo oscuro di debolezza e dipendenza, che rimane negli stessi soggetti considerati autonomi» (p. 47)
Le ricadute di questa visione non sono poche, non ultima la necessita di rovesciare il metodo principiale (deduttivo, gerarchico, discendente) in uno di cura (induttivo, plurale, prudentemente ascendente). Aprirsi alle voci differenti significa stimolare un movimento eccentrico per il soggetto morale, spostarlo dalla sua prospettiva abituale, e non semplicemente tener conto della presenza di soggetti deboli di cui aver cura.
In questa linea di rilettura delle bioetica principiale si colloca l’attenzione mostrata nel volume per Hans Jonas, guarda caso un filosofo che ha sempre visto la sua riflessione su temi cardine della bioetica contemporanea come la stretta continuazione del suo lavoro di pensatore e di quella originalissima metabolizzazione e ibridazione (tale a volte da farlo apparire su moltissime questioni con posizioni di segno opposto) della lezione del suo maestro Heidegger. Ma Jonas non è solo il simbolo di una bioetica che non cessa di essere filosofia ma altresì il filosofo della responsabilità, che la Gensabella connette alla cura attraverso la comune discendenza da un riconoscimento nell’uomo di una matrice di vulnerabilità (in Jonas di schietta discendenza hobbesiana). Di un utilizzo del pensiero di Jonas però si mettono in luce anche i rischi, ad esempio lo schiacciamento sul paradigma genitoriale, con l’implicito problema di coniugare cura ed autonomia, nonché cura verso chi non è apparentemente bisognoso. Acutamente l’autrice mostra come altri paradigmi (quello della fraternità ad esempio) non si inserirebbero in un sistema come quello jonasiano che si lega strettamente al timore per il futuro.
Se il timore del futuro, del piano inclinato, dell’esperienza del limite (come recita il titolo) è importante, non lo è meno però la situazione normale, una «bioetica quotidiana che non fa notizia, e che dovrebbe invece farla, svegliando le coscienze di tutti sulle scelte che ogni giorno da noi o da altri vengono compiute nel campo delle scienze della vita e della cura della salute: l’allocazione delle risorse sanitarie» (p. 67). La bioetica dovrebbe dunque frequentare il limite ma non dimenticare che anche nelle condizioni normali essa ha occasione di indurre riflessioni più profonde sul nostro modo di pensare categorie come quelle della tecnica o della salute. Del resto, come si mostra in uno dei saggi centrali del libro (Cura e rispetto), per quanto siano i limiti e le nuove esperienze a stimolare la riflessioni, le radici delle questioni “attuali” sono millenarie. Così la conversazione up to date sui diritti delle scimmie antropomorfe ci riporta, ad esempio, all’antica questione di cosa faccia dell’uomo un uomo. Al bioetico dunque l’onore e l’onere di tendersi verso il nuovo senza recidere le millenarie radici che lo legano alle questioni fondamentali.
| Marianna Gensabella Furnari |
| Vulnerabilità e cura. Bioetica ed esperienza del limite |
| Rubettino, Soveria Mannelli (CS) 2008 |
| Pagine 272 |
Nessun commento