Io ricordo
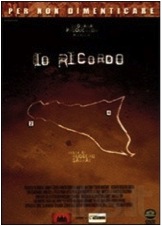 Io ricordo è un film documentario del 2008 del regista Ruggero Gabbai. Il trait d’union dei delitti di mafia, presentati sotto forma di intervista ai familiari delle vittime, è la storia di un padre che decide di parlare al figlio Giovanni della mafia anche per spronarlo a non subire passivamente gli atteggiamenti antisociali di un compagno di scuola.
Io ricordo è un film documentario del 2008 del regista Ruggero Gabbai. Il trait d’union dei delitti di mafia, presentati sotto forma di intervista ai familiari delle vittime, è la storia di un padre che decide di parlare al figlio Giovanni della mafia anche per spronarlo a non subire passivamente gli atteggiamenti antisociali di un compagno di scuola.
Heidegger, in Essere e tempo, ha spiegato come l’uomo tenga presente la morte in modo inadeguato. Appartiene a un “si” anonimo, che sembra non aver nulla a che fare con noi. La quotidianità elude il nostro esser-per-la-morte, non lo prende sul serio e ci spinge alla dispersione. È sempre dell’altro -la morte- di un generico Caio che nulla sa dell’amore, dell’odore, dell’abbraccio, della risata, del dolore. In questo film Caio ha invece nome e cognome, famiglia e amici, emozioni e sentimenti, paura e coraggio. E tiene-per-vera la propria morte, ponendosi in un orizzonte di attesa, affinché all’immobilismo di un vivere come se fossimo eterni si sostituisca un’azione -che segni il futuro, e la scelta consapevole -che non disperda le possibilità. Una tale coscienza dovrebbe riguardare tutti gli esseri umani. Assumere con certezza la nostra morte come la possibilità più propria del nostro esistere significa certamente aprirsi all’angoscia, ma ci evita di finire disperatamente incompiuti e permette di operare scelte eterne. Non bisogna essere votati al sacrificio per farlo o eroi ma amare fino in fondo la propria vita, fino al punto da sapere con assoluta sicurezza che se il “respiro successivo è sempre un dono” allora ogni momento deve essere vissuto nella piena totalità.
L’impresa compiuta da Ruggero Gabbai in Io ricordo ha un valore altamente didattico, ma anche e soprattutto politico. Nel film non si è potuto parlare ovviamente di tutte le vittime, ma per la prima volta si è dato spazio anche ai nomi meno eccellenti, a quei morti di cui pochi sanno. Affinché si possa comprendere la pervasività della mafia e rifiutarla veramente in costante rivolta, è necessario conoscerne l’intero territorio delittuoso della storia dei suoi assassinii, averne una mappa mentale che consenta di non isolare i singoli crimini ma di spazio-temporalizzarli e visualizzarli nella rete che ha tessuto, nella mattanza che ha compiuto. È necessario comprendere che la sua azione diabolica non si ferma all’uccisione di chi vi si oppone o di chi ne intralcia le vili faccende, non è regionale, ma entra come linfa mortale nel tessuto sociale dell’intera nazione; avvelena il popolo muto con i voti di scambio, le raccomandazioni, i favori, le protezioni, la minaccia velata, le promesse; si nutre dell’accettazione passiva del cittadino, della sua ignoranza, dei suoi bisogni, del suo egoismo, della sua paura; opera per far morire una seconda volta le sue vittime, alimentando la delegittimazione e l’oblio della loro memoria.
 La conclusione del film, che tocca il suo vertice emotivo nel racconto della strage di Capaci, apre alla certezza che il muro di silenzio è stato abbattuto, che la rivolta dell’onestà compiuta da quelle vittime -che sono i nostri morti- ha messo dei paletti definitivamente inamovibili su cui costruire il futuro di ognuno. Il figlio, a cui l’attore Gianfranco Jannuzzo, nelle vesti del padre, racconta la verità della mafia, diviene un simbolo. Si chiama Giovanni perché nato il 23 maggio del 1992, il giorno della morte di Falcone. Rappresenta la rinascita, il futuro, la speranza, rese possibili proprio grazie all’impegno di quegli eroi, condotto sino alle estreme possibilità, sino «all’impossibilità di ogni altra possibilità» e con un coraggio diametralmente opposto alla vigliaccheria meschina della mafia. E ogni bambino, da sud a nord, deve il suo avvenire a quelle morti, deve l’ampliarsi del raggio delle sue future scelte a quei combattenti. La scuola ha un compito nella formazione dell’uomo e del cittadino: ricordare, impedire l’ignoranza, lottare contro l’oblio, perché ognuno comprenda la necessità del proprio impegno.
La conclusione del film, che tocca il suo vertice emotivo nel racconto della strage di Capaci, apre alla certezza che il muro di silenzio è stato abbattuto, che la rivolta dell’onestà compiuta da quelle vittime -che sono i nostri morti- ha messo dei paletti definitivamente inamovibili su cui costruire il futuro di ognuno. Il figlio, a cui l’attore Gianfranco Jannuzzo, nelle vesti del padre, racconta la verità della mafia, diviene un simbolo. Si chiama Giovanni perché nato il 23 maggio del 1992, il giorno della morte di Falcone. Rappresenta la rinascita, il futuro, la speranza, rese possibili proprio grazie all’impegno di quegli eroi, condotto sino alle estreme possibilità, sino «all’impossibilità di ogni altra possibilità» e con un coraggio diametralmente opposto alla vigliaccheria meschina della mafia. E ogni bambino, da sud a nord, deve il suo avvenire a quelle morti, deve l’ampliarsi del raggio delle sue future scelte a quei combattenti. La scuola ha un compito nella formazione dell’uomo e del cittadino: ricordare, impedire l’ignoranza, lottare contro l’oblio, perché ognuno comprenda la necessità del proprio impegno.
I grandi protagonisti del film –le vittime e i loro familiari- portano se stessi in modo autentico, gli uni il coraggio e l’impegno, gli altri il dolore, puro e spontaneo, la rabbia, la solitudine e in taluni casi anche la fierezza nella voce e nello sguardo che è l’orgoglio dei loro morti. Lo stesso Gianfranco Jannuzzo, noto attore di teatro, si dà al cinema in quest’opera in modo sincero. Il mattatore eccellente che trasforma la finzione in realtà, immedesimandosi nel ruolo dei personaggi, qui, si arrende al fastidio, emotivamente comprensibile, di rappresentare la propria carne siciliana nelle vesti di un altro. La verve di Jannuzzo, la sua passione, la sua risata seria e trascinante, qui, prendono il posto di un sentire palpabile –figlio della commozione più intima- che lo sprona a ribellarsi alla menzogna della recitazione, ad assumere se stesso, l’altro lato della sua sicilianità, fino in fondo. Sembra quasi a disagio, dunque, a interpretare un uomo che non è lui, ma le cui parole sono così carnalmente a lui appartenenti. Indossare la maschera in questo film non è possibile, Jannuzzo porta il suo volto, piuttosto, tutt’intero e magistralmente. Rabbia e commozione, infatti, investono lo spettatore Jannuzzo, a cui urlano gli occhi mentre la bocca parla decisa, a cui piangono le mani mentre mostra il paesaggio di fronte alla collinetta di Capaci. E chi da lui è condotto nella via della comprensione si affida alla sua emozione e alla sua forza, aprendosi alla narrazione toccante e drammatica dei familiari di quelle vittime -a cui, come grida a gran voce Nichi Vendola, «noi dobbiamo la nostra decenza»- e in tal modo cogliendo la volgarità della mafia e la ferita inferta al mondo.
Un film che dovrebbe essere considerato da ogni insegnante un utile strumento didattico e presentato agli studenti di ogni ordine e grado. Io l’ho fatto.
| Ruggero Gabbai |
| Io ricordo |
| Liberamente tratto dal libro Per questo mi chiamo Giovanni di Lugi Garlando (Fabbri Editori) |
| Italia, 2008 |
| Musiche di Francesco Buzzurro |
| Con Gianfranco Jannuzzo, Pietro La Cara |
Un Commento