Il sacrificio, la carne e gli animali
Esiste un rapporto tra l’odierno consumo di carne animale e la sfera sacrificale? Le categorie sacrificali antiche possono aiutarci per comprendere meglio l’alimentazione carnea contemporanea? Il sacrificio deve o no essere considerato una struttura fondativa ineluttabile dell’essere umano, e se sì, fondativa di cosa? Il gesto vegetariano, oltre a esprimere un rifiuto individuale della violenza, può essere letto come un rifiuto dell’intero ordine sociale? A queste domande tenta di rispondere Françoise Armengaud in Réflexions sur la condition faite aux animaux, appena pubblicato presso le edizioni Kimé.
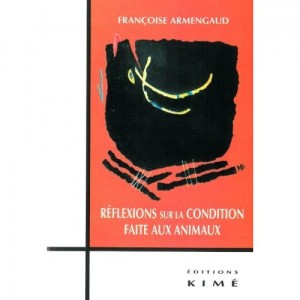 Armengaud è agrégée e dottore di ricerca in filosofia, già maître de conférences di filosofia del linguaggio ed estetica all’università Paris X nonché redattrice di Nouvelles Questions Féministes, storica rivista internazionale di femminismo materialista e radicale. Questo suo nuovo volume raccoglie ed elabora articoli pubblicati negli ultimi venti anni su svariati temi uniti da un filo conduttore: la riflessione, critica e sdegnata, sulle relazioni tra gli umani e gli animali e in particolare sull’uso che i primi fanno dei secondi, nei concetti e nelle pratiche. I diversi argomenti affrontati spaziano dall’interpretazione estetica della rappresentazione degli animali -nel cinema, nell’arte, nella poesia- alla loro interpretazione politica, che mostra come, attraverso sofismi e accostamenti ideologici, tale rappresentazione ricopra una funzione giustificativa di numerose frammentazioni politiche dello spazio sociale umano. All’interno di questo vasto materiale, che sarebbe impossibile presentare in modo esauriente e complessivo, abbiamo scelto di concentrarci sull’analisi operata da Armengaud del rapporto tra la categoria del «sacrificio» e l’alimentazione carnea.
Armengaud è agrégée e dottore di ricerca in filosofia, già maître de conférences di filosofia del linguaggio ed estetica all’università Paris X nonché redattrice di Nouvelles Questions Féministes, storica rivista internazionale di femminismo materialista e radicale. Questo suo nuovo volume raccoglie ed elabora articoli pubblicati negli ultimi venti anni su svariati temi uniti da un filo conduttore: la riflessione, critica e sdegnata, sulle relazioni tra gli umani e gli animali e in particolare sull’uso che i primi fanno dei secondi, nei concetti e nelle pratiche. I diversi argomenti affrontati spaziano dall’interpretazione estetica della rappresentazione degli animali -nel cinema, nell’arte, nella poesia- alla loro interpretazione politica, che mostra come, attraverso sofismi e accostamenti ideologici, tale rappresentazione ricopra una funzione giustificativa di numerose frammentazioni politiche dello spazio sociale umano. All’interno di questo vasto materiale, che sarebbe impossibile presentare in modo esauriente e complessivo, abbiamo scelto di concentrarci sull’analisi operata da Armengaud del rapporto tra la categoria del «sacrificio» e l’alimentazione carnea.
Prima di addentrarci in questa direzione, è bene introdurre una precisazione: le riflessioni proposte in questo libro non si limitano mai a una semplice trattazione del ruolo dell’animale come sostituto simbolico dell’umano, che si tratti del sacrificio o in generale dell’uso politico dell’animalità. Armengaud puntualizza in modo costante, insistente, che al cuore delle sue riflessioni ci sono gli animali: «così come noi li trattiamo, nei nostri gesti e condotte, nell’organizzazione massiccia e crudele del loro sfruttamento e nell’assassinio insito nel loro abbattimento»; ma anche «gli animali e il piacere che ci suscita la loro bellezza e, a volte, un’amicizia che non siamo mai sicuri di meritare» (pp. 13-14). Nel caso del suo studio delle teorie antropologiche del sacrificio, Armengaud scrive: «preciso che il mio interesse per l’antropologia è un interesse in qualche modo obliquo: dal punto di vista degli animali. Con questo vorrei anche indicare un punto cieco dell’antropologia classica, ovvero la sua non interrogazione sull’essere dell’animale, il cui essere vittima va da sé» (p. 77).
Per poter affrontare la problematica del sacrificio in relazione al consumo di carne, occorre in primo luogo precisare la nozione stessa di «sacrificio». «In senso stretto, il sacrificio rientra nella categoria del rito», e questo è definibile come «una sequenza di gesti e di azioni regolati nel loro ordine e successione, ripetuti periodicamente […] che riveste un carattere sacro o simbolico» (p. 62). In senso più generico, poi, il sacrificio costituisce una categoria mentale e culturale che ingloba atti «apparentemente non rituali, cioè non riconosciuti come sacrifici da coloro che li praticano, ma pensabili come tali» (p. 63). Ma di che tipo di rito si tratta, specificamente? Armengaud, dopo aver presentato tre esempi di cultura sacrificale religiosa (il sacrificio brahmano nello hinduismo, il sacrificio nell’antica polis greca e l’Ayd-el-Kébir, il sacrificio domestico musulmano che ricalca quello di Abramo) abbozza una prima definizione «minimalista e astratta [… secondo cui il sacrificio] è la soppressione di un valore a profitto di un altro valore, soppressione che si ritiene avvantaggiare questo altro valore, se non addirittura crearlo; […] per esempio, per un individuo, “essere sacrificato” significa (agli occhi dei suoi sacrificatori) vedersi attribuito un valore minore e/ma degno di, e atto a produrre, attraverso il proprio annientamento, un valore maggiore» (p. 76). Sulla base di questa idea generale possono essere esaminate le diverse teorie antropologiche del sacrificio -le quali concordano nel definire come sue finalità principali la comunicazione tra gli umani e gli antenati o gli dei, e il mantenimento di un ordine sociale e/o cosmico- arrivando a definire, schematicamente, due categorie principali di sacrificio: quello in cui la vita animale funziona come doppio della vita umana e quello in cui vale per se stessa.
Nel primo caso, il valore del sacrificio è essenzialmente espiatorio: esso assicura la riparazione di un torto verso gli dèi e la restaurazione della struttura cosmica o sociale. Rito cruento di purificazione, in cui «l’animale deve essere visto come rappresentazione proiettiva, o modello, dell’essere umano» (p. 78). Lo status della vittima è riconducibile alla categoria degli «excreta (ciò che è eliminato, espulso), nella quale la finalità del sacrificio è scacciare qualcosa al di fuori del corpo sociale, espellerlo [… e] in cui gli animali sono secondari. [… ] Qui alcuni umani, per esempio nella persone di re e capi, sono primari, altri umani (schiavi, progenitura) possono essere loro sostituiti, e infine degli animali possono rimpiazzare questi ultimi. […] Mangiato o no, l’animale è in primo luogo un sostituto ed è ugualmente sostituibile da un animale di specie diversa» (p. 84).
La seconda categoria di sacrificio ha valore domestico: lo status della vittima è riconducibile alla categoria degli «ingesta (ciò che è ingerito, mangiato), il sacrificio riguarda principalmente il cibo e in esso gli animali sono prioritari, cioè non sono sostituti di umani» (p. 84). In questa tipologia di sacrificio, il rito si configura come dono e prevede una ripartizione delle carni dell’animale ucciso tra commensali trascendenti (divinità, antenati, spiriti…) e commensali terreni, gli umani sacrificanti membri di un preciso gruppo sociale (tribù, città…); ripartizione che segue regole estremamente precise quanto a preparazione, cottura e distribuzione delle parti. La finalità del sacrificio non è qui nell’idea di restaurazione ma di preservazione, di conferma della struttura del mondo, cosmico o umano.
Françoise Armengaud individua numerosi punti di divergenza tra le due categorie (pp. 85-87), le quali sono da lei riconosciute come compatibili e conciliabili proprio in quanto si spartiscono la sfera sacrificale senza coincidere. Tra questi, la divergenza delle modalità di uccisione: indolore per quanto possibile, o comunque senza sofferenza aggiunta, nel caso degli ingesta; dolorosa e con sofferenza insistentemente inflitta, secondo il modello del linciaggio, nel caso degli excreta. O ancora, quella delle qualità richieste alla vittima: animale sano, perfetto, «puro», nel caso degli ingesta, laddove gli excreta non debbono avere requisiti particolari. Fondamentale poi quella che riguarda la giustificazione e lo scopo del sacrificio: l’uccisione dell’ingestum è un’offerta finalizzata alla coesione sociale tramite la ripartizione delle risorse, un dono che dà luogo alla circolazione e allo scambio, in questo caso dell’alimento, mentre quella dell’excretum è un’espiazione, finalizzata alla salvezza del collettivo attraverso l’immolazione di uno solo. «In ultima analisi, nel caso degli ingesta si tratta per gli umani di mangiare; nel caso degli excreta, di non essere mangiati dagli altri umani» (p. 86).
 Nell’idea del sacrificio come rito catartico avente per oggetto degli excreta, il lettore avrà certamente riconosciuto la teoria di René Girard, secondo la quale esiste una struttura sacrificale socialmente fondante, e quindi necessaria e inaggirabile, il cui fine è canalizzare la violenza individuale in un atto di violenza collettiva, esercitato su di un capro espiatorio, per costituire e garantire la pace sociale. Ma Armengaud, appoggiandosi alle critiche di altri autori, contesta tale teoria per il suo riduzionismo: Girard, dice Armengaud seguendo Heusch, «ha il difetto di abolire tutte le differenze antropologiche in virtù di una concezione psicologica arbitratria della vita sociale» (p. 83); e ancora, seguendo Pommier, Girard «considera (a torto), in primo luogo che ci sono solo sacrifici cruenti; in secondo luogo che i sacrifici di animali sono essenzialmente sostitutivi, dei sacrifici umani camuffati» (ibidem). Come abbiamo visto nella ricostruzione di Françoise Armengaud, invece, non tutti i sacrifici corrispondono alla teorizzazione girardiana, non tutti i riti sacrificali sono riti terapeutici volti a contenere e sublimare la violenza umana: una tale teoria unitaria del sacrificio non rende conto della complessità delle funzioni e delle pratiche e va quindi rifiutata in quanto semplificatoria. Quel che più interessa rispetto alla finalità complessiva del lavoro di Armengaud è che rifiutare di interpretare il sacrificio unicamente nei termini proposti da Girard permette di poter pensare più facilmente un’uscita dalla logica sacrificale, uscita che Girard invece non ritiene né possibile né augurabile.
Nell’idea del sacrificio come rito catartico avente per oggetto degli excreta, il lettore avrà certamente riconosciuto la teoria di René Girard, secondo la quale esiste una struttura sacrificale socialmente fondante, e quindi necessaria e inaggirabile, il cui fine è canalizzare la violenza individuale in un atto di violenza collettiva, esercitato su di un capro espiatorio, per costituire e garantire la pace sociale. Ma Armengaud, appoggiandosi alle critiche di altri autori, contesta tale teoria per il suo riduzionismo: Girard, dice Armengaud seguendo Heusch, «ha il difetto di abolire tutte le differenze antropologiche in virtù di una concezione psicologica arbitratria della vita sociale» (p. 83); e ancora, seguendo Pommier, Girard «considera (a torto), in primo luogo che ci sono solo sacrifici cruenti; in secondo luogo che i sacrifici di animali sono essenzialmente sostitutivi, dei sacrifici umani camuffati» (ibidem). Come abbiamo visto nella ricostruzione di Françoise Armengaud, invece, non tutti i sacrifici corrispondono alla teorizzazione girardiana, non tutti i riti sacrificali sono riti terapeutici volti a contenere e sublimare la violenza umana: una tale teoria unitaria del sacrificio non rende conto della complessità delle funzioni e delle pratiche e va quindi rifiutata in quanto semplificatoria. Quel che più interessa rispetto alla finalità complessiva del lavoro di Armengaud è che rifiutare di interpretare il sacrificio unicamente nei termini proposti da Girard permette di poter pensare più facilmente un’uscita dalla logica sacrificale, uscita che Girard invece non ritiene né possibile né augurabile.
Le riflessioni di Armengaud, difatti, non sono mai meramente descrittive, ma sono percorse da un intento politico: la «speranza a lungo termine» (p. 30) che l’oppressione degli animali possa un giorno essere abolita. Nel caso delle pratiche sacrificali, si tratta di capire il nesso, se un nesso esiste, fra tali pratiche e l’odierno consumo di carne nelle società industrializzate contemporanee, per arrivare infine a chiedersi: «che fare per uscire dalla sfera dei sacrificabili e dei sacrificati?» (p. 87).
Abbiamo già visto come lo schema del sacrificio come espiazione non sia realmente legato all’atto del mangiare. Quanto allo schema del sacrificio come dono, secondo Armengaud esso non è direttamente applicabile all’alimentazione carnea attuale, perché in esso una parte della vittima deve sempre essere riservata al commensale trascendente (la divinità), laddove il consumatore di oggi «non dà nulla e prende tutto, non dà ad altri che a sé. È ancora possibile pensare il pasto carneo in termini di oblazione [solo] a condizione di vedere, in termini contemporanei, il cibo-carne come sacrificio offerto a sé per vivere, soddisfare l’appetito, il gusto, la golosità, rinnovare l’energia» (pp. 75-76). Un ulteriore elemento di non corrispondenza tra categorie sacrificali antiche e relazione attuale con gli animali-vittime risiederebbe poi nel fatto che «al giorno d’oggi sembra che trattiamo i nostri ingesta come degli excreta, attraverso il disprezzo che abbiamo per loro, disprezzo evidente nelle modalità di vita che infliggiamo loro e nella loro distruzione di massa» (p. 88). Dobbiamo forse concludere allora che i comportamenti di oggi siano poco o per niente leggibili come espressioni di una mentalità sacrificale?
Pur concordando con Françoise Armengaud sull’idea che il sacrificio «non fornisce una spiegazione ultima della violenza esercitata sugli animali» (p. 89), è nostro avviso che esistano altre caratteristiche del sacrificio oblativo potenzialmente utili per comprendere, almeno in parte, alcuni aspetti del moderno sistema di produzione e consumo dell’alimento-carne. Sulla base dei saggi del grecista ed antropologo Marcel Detienne raccolti nel volume La cuisine du sacrifice en pays grec, ci sembra di poter individuare almeno due tratti del sacrificio quale era praticato nella Grecia antica che sono riferibili alla nostra attualità.
Il primo è la relazione tra il mangiar carne e l’ordine sociale. Come già visto, il sacrificio con finalità oblativa prevede una distribuzione strettamente codificata delle parti del corpo della vittima ai commensali; si tratta di una spartizione che rispecchia le gerarchie politiche della società sacrificante. Secondo Marcel Detienne, in Grecia l’alimentazione carnea coincideva in modo assoluto con la pratica sacrificale1. Esistevano due sistemi di spartizione: uno basato sul privilegio (ghèras), in cui le porzioni più pregiate erano assegnate ai capi (sacerdoti, re, magistrati); e uno, analogo del pasto omerico a parti uguali, in cui il corpo della vittima era smembrato in pezzi di uguale peso che venivano tirati a sorte. I due sistemi potevano combinarsi: prelievo delle porzioni pregiate per i commensali di rango particolare e distribuzione egalitaria del resto2. Le categorie di abitanti marginali, i non-cittadini, non partecipavano al sacrificio e al pasto carneo se non sotto precise condizioni: gli stranieri solo attraverso la mediazione di un cittadino che rispondesse pubblicamente di loro; i meteci erano esclusi dal sacrificio ma potevano essere ammessi tra i commensali; quanto alle donne, costituivano, nelle le parole di Detienne, «la categoria più rilevante dei marginali nel sacrificio»3. Lo status delle donne nel sacrificio corrispondeva esattamente al loro status politico: private di tutti i diritti politici, esse erano dunque escluse dagli altari, dalla carne e dal sangue, salvo circostanze eccezionali nelle quali entravano in gioco unicamente le donne sposate con dei cittadini, solo attraverso la mediazione del marito e, nei termini della gerarchia, ricevendo la loro porzione solo dopo i maschi della famiglia4. Non è forse possibile cogliere strutture analoghe regolanti il consumo di carne e la ripartizione degli animali (in quanto «pezzi» e in quanto specie) nelle società moderne secondo criteri fondati sulla classe sociale, quindi sulla cittadinanza e sul peso politico? Spartizione laica, impersonale, che si impone da sé, in cui il classismo capitalista (carni scelte, ed eventualmente «biologiche» o di specie più rare o difficili da allevare, per i ricchi; carni più ordinarie, o di «minore qualità», per gli altri) si interseca con simbologie patriarcali (carni rosse e al sangue per gli uomini, carni bianche, o pesce, o formaggi, per le donne).
In questa cornice, è interessante interrogarsi sulla posizione sociale dei «disertori» dell’alimentazione carnea. Detienne dedica alcune pagine ai gruppi filosoficamente e religiosamente dissidenti dell’Antichità, avversi al sacrificio e più o meno «vegetariani» (correnti pitagoriche, orfiche, dionisiache), e osserva che «sono le forme di protesta, rese esplicite dai diversi orientamenti del misticismo greco, che permettono di cogliere le regole implicite e di far apparire le grandi articolazioni del sistema sacrificale»5. Se cioè il sistema delle pratiche religiose-alimentari scaturisce da un fondo ancestrale tacito che i Greci non sentono il bisogno di definire in modo manifesto e razionale, sono le voci discordi che ne tracciano i contorni proprio attraverso la protesta. E non si può forse dire che oggi le critiche sempre più numerose dell’uccisione di animali a scopo alimentare, da parte di un movimento vegetariano che guadagna costantemente in visibilità, sfidano il sistema carnivoro a uscire dal confortante alveo della tacita legittimazione storico-culturale per impegnarsi in auto-giustificazioni filosofiche aperte (e, a dire il vero, non sempre convincenti)?
Il secondo tratto del sacrificio potenzialmente riferibile all’attualità riguarda il modo in cui i mangiatori di carne si rapportano alle vittime, gli animali, e in particolar modo alla loro sofferenza. Come abbiamo visto, nel rito sacrificale che ha per vittime gli ingesta è prescritto di evitare quanto più possibile la sofferenza. Ciò è vero anche nel sacrificio greco: Detienne parla di una «volontà di cancellare la violenza nella cerimonia sacrificale, come se si trattasse di discolparsi in anticipo dell’accusa di assassinio»6, e descrive il modo in cui l’animale viene accompagnato all’altare in processione, senza fretta né costrizione apparente, il coltello, sottile e affilato per una morte rapida, nascosto in un cesto sotto chicchi d’orzo mischiati a sale. Addirittura, «il rituale si preoccupa di ottenere il suo consenso attraverso il movimento della testa»: la procedura vuole che gli si spargano addosso all’improvviso acqua fredda e poi semi, il che lo induce a scuotere la testa, per sgrullarsi, gesto interpretato come segno di assenso7. Per lo stesso motivo, davanti all’altare l’animale, fino ad allora allevato in libertà perché destinato a essere sacrificato, viene indotto ad abbassare il capo, come nel gesto di assoggettarsi al giogo, ulteriore manifestazione di consenso8. Ora, Françoise Armengaud ha certamente ragione nell’evocare il disprezzo per l’animalità espresso dalle attuali modalità industriali di allevamento e uccisione delle bestie. Ma se pensiamo all’importanza che gran parte della nostra società, pur non aderendo al vegetarismo –anzi, proprio per il fatto di non aderire al vegetarismo- accorda all’idea di «benessere» animale e alla riduzione della sofferenza negli allevamenti e nei mattatoi, e accostiamo questa esigenza sociale odierna alla struttura del sacrificio greco, ecco una nuova affinità. Anche la nostra società, come quella greca, ha bisogno di rimuovere il più possibile le tracce di violenza dall’idea dell’uccisione degli animali. È l’organizzazione economica capitalista, con la sua massificazione e la sua tecnologia, a rendere materialmente impossibile la realizzazione di questa «impostura». Ecco allora che, in epoca moderna, le macellazioni cominciano a non essere più praticate per strada ma in luoghi chiusi e centralizzati, i mattatoi, che progressivamente si spostano sempre più lontano dal centro della città, dal cuore della vita sociale. Ed ecco che, parallelamente, la comunicazione di massa comincia a lavorare sull’immagine degli animali di allevamento: colorati, buffi, sorridenti, consenzienti. Laddove Armengaud afferma che «trattiamo i nostri ingesta come degli excreta», è necessario aggiungere che continuiamo ad aver bisogno di pensarli come ingesta.
 Nella conclusione delle sue riflessioni sul sacrificio, la filosofa francese afferma che «sembra facile (o almeno si può immaginare senza difficoltà) uscire dal sacrificio degli ingesta, smettere di nutrirsi […] di carne animale. Ma è dal sacrificio di violenza fondatrice, dal sacrificio politico degli excreta, che sembra più difficile uscire. Sacrificio che comprende anche le guerre e i massacri tra umani» (p. 88). Se una vera risposta al problema dell’uscita dalla mentalità sacrificale è ancora di là da venire, il merito di Armengaud sta sicuramente nell’aver chiarito alcuni presupposti importanti del problema stesso, mostrando in che termini e a che condizioni si può dire che tale mentalità sia in relazione con il mangiar carne. Un chiarimento che permette di evitare letture univoche troppo affrettate. La struttura del sacrificio è probabilmente una componente delle relazioni che intratteniamo con gli animali al giorno d’oggi, ma ciò non vuol dire che sia univoca, né che sia l’unica. E se gli animali assumono ancora oggi le vesti di esseri metaforici, utilizzati come sostituti di umani e destinatari obliqui della violenza umana, come sostiene Girard, ciò non significa che questo sia il loro ruolo unico, o principale. Come abbiamo visto, alcune pratiche sacrificali si esercitano sugli animali non in quanto capri espiatorî ma in quanto esseri commestibili e trattano la violenza della loro messa a morte come un effetto collaterale da minimizzare e rimuovere. Si tratta di due visioni dell’animale essenzialmente diverse e non sovrapponibili, nelle quali emergono fattori di tipo eterogeneo che, pur eventualmente intersecandosi, non possono riassumersi gli uni negli altri.
Nella conclusione delle sue riflessioni sul sacrificio, la filosofa francese afferma che «sembra facile (o almeno si può immaginare senza difficoltà) uscire dal sacrificio degli ingesta, smettere di nutrirsi […] di carne animale. Ma è dal sacrificio di violenza fondatrice, dal sacrificio politico degli excreta, che sembra più difficile uscire. Sacrificio che comprende anche le guerre e i massacri tra umani» (p. 88). Se una vera risposta al problema dell’uscita dalla mentalità sacrificale è ancora di là da venire, il merito di Armengaud sta sicuramente nell’aver chiarito alcuni presupposti importanti del problema stesso, mostrando in che termini e a che condizioni si può dire che tale mentalità sia in relazione con il mangiar carne. Un chiarimento che permette di evitare letture univoche troppo affrettate. La struttura del sacrificio è probabilmente una componente delle relazioni che intratteniamo con gli animali al giorno d’oggi, ma ciò non vuol dire che sia univoca, né che sia l’unica. E se gli animali assumono ancora oggi le vesti di esseri metaforici, utilizzati come sostituti di umani e destinatari obliqui della violenza umana, come sostiene Girard, ciò non significa che questo sia il loro ruolo unico, o principale. Come abbiamo visto, alcune pratiche sacrificali si esercitano sugli animali non in quanto capri espiatorî ma in quanto esseri commestibili e trattano la violenza della loro messa a morte come un effetto collaterale da minimizzare e rimuovere. Si tratta di due visioni dell’animale essenzialmente diverse e non sovrapponibili, nelle quali emergono fattori di tipo eterogeneo che, pur eventualmente intersecandosi, non possono riassumersi gli uni negli altri.
Queste precisazioni inducono a pensare che il superamento della violenza infra-umana da realizzarsi attraverso una rifondazione sociale e culturale delle relazioni umane, un passaggio certamente indispensabile per uscire dalla logica del sacrificio espiatorio, è premessa necessaria ma non sufficiente in sé per uscire dal sacrificio degli ingesta e dalle pratiche carnivore in generale. Uscita che richiede una condizione supplementare: la disponibilità ad abbandonare l’immagine degli animali come esseri commestibili, ovvero ad ipotizzare relazioni con gli animali che non passino attraverso dinamiche alimentari. E su quest’ultimo punto che chiude la nostra riflessione, ci permettiamo di dissentire da Françoise Armengaud: che una tale disponibilità possa nascere «facilmente» sul piano collettivo ci sembra tutto da dimostrare.
Note
1. M. Detienne, « Pratiques culinaires et esprit du sacrifice », in M. Detienne e J.-P. Vernant (a cura di), La cuisine du sacrifice en pays grec, Gallimard, Paris 1979, p. 10. V. anche p. 21: «tutta la carne consumabile deve provenire da un abbattimento rituale».
3. Id., «Violentes “eugénies“. En pleines Thesmophories: des femmes couvertes de sang», in M. Detienne e J.-P. Vernant (a cura di), La cuisine du sacrifice en pays grec, cit., p. 186.
5. M. Detienne, « Pratiques culinaires et esprit du sacrifice », cit., p. 12.
Nessun commento