Antonio Calderara, artista e personaggio
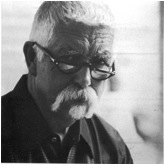 Lo si vedeva in via Montenapoleone a Milano, come un signore d’altri tempi, dandy di un dandismo particolare, che lo metteva comunque al di fuori dallo schema obsoleto del perdigiorno, Signore borghese a spasso nel centro della città.
Lo si vedeva in via Montenapoleone a Milano, come un signore d’altri tempi, dandy di un dandismo particolare, che lo metteva comunque al di fuori dallo schema obsoleto del perdigiorno, Signore borghese a spasso nel centro della città.
Antonio Calderara era anche all’apparenza, classico e trasgressivo al contempo. In inverno, chiuso nel cappotto di cammello a doppiopetto, la zazzera bianca, i baffi risorgimentali. La sua figura era completata da un bassotto in tinta al cappotto. Entrava nelle gallerie, allora tutte concentrate nelle vie del centro, con il suo elegante accompagnatore, una virgola. All’angolo di via Rossini con via S.Spirito c’era ancora la galleria Barbaroux, importante per l’arte figurativa del Novecento, cui l’artista aveva appartenuto, sia pure senza mai mettervi radice così come avrebbe meritato.
È stato in quelle vie, tra mondanità di belle vetrine e caffè dai mitici aperitivi, che anche io e il mio amico Sergio Tosi, poco più che ventenni, lo conoscemmo.
Avevo trovato un lavoretto a Sergio, studente di architettura fuori corso, curioso un po’ di tutto, in cerca di decidere cosa fare davvero nella vita. Il lavoretto consisteva nel tenere aperta la galleria Dell’Indiano, la cui sede storica era a Firenze, con recente succursale milanese. Sergio si destreggiava benissimo, tra inviti, telefonate, allestimenti, chiacchiere con i visitatori, alcuni dei quali poi divennero amici e collezionisti. Nel piccolo soppalco dove si trovava la scrivania c’era anche un lettino sul quale, eventualmente, si poteva anche fare dell’altro nei lunghi pomeriggi in cui non c’era pubblico, il cui arrivo era comunque segnalato dalla campanella fissata alla porta d’ingresso, subito dentro al cortile, dominato da una bella palma, che esiste tuttora. Gli antichi palazzi nella via elegante di Milano, allora, non erano ancora stati ristrutturati, lucidati, ma conservavano quella patina di signorile distacco dall’eccesso di cura, che manteneva il loro contatto con la storia che li aveva creati, e invecchiati. Nel lettino, o come si diceva ancora, nella ottomana, dormiva quando veniva a Milano il titolare della galleria, Piero Santi, e anche il suo amico, del quale ricordo solo il cognome, Marini. La Galleria Dell’Indiano aveva fatto la propria fortuna con Ottone Rosai e proponeva a Milano il suo gruppo di fiorentini che altrimenti, a Milano, non avrebbero avuto spazio. Sembra incredibile ma allora era proprio così, nei primi anni ’60, ogni città si teneva i propri artisti.
Calderara divenne subito amico di Sergio e anche mio. Uomo che ci appariva anziano assai più di quanto non fosse, cordiale, curioso, con un modo di fare autorevole ma confidenziale, la parlata arricchita ogni tanto dal milanese, come si usava un tempo fare, nella buona borghesia.
Conoscemmo più tardi, oltre all’eccentrico duo, artista e cane lineare, la moglie Carmela, bellissima signora, il volto di porcellana, i capelli grigi ondulati stretti dietro al capo in un piccolo codino legato da un nastrino di raso colorato. Un viso triangolare tracciato da belle rughe che invece di appesantirlo, lo assecondavano, occhi azzurro intenso, contornati dal bistro nero. Cipria bianca e labbra sottili, rosso vivo. Una statuina anni trenta, compreso il collo, lungo e magro, non disturbato dagli anelli che lo solcavano, mentre sbucava dal colletto dell’abito dallo scollo a punta, quasi sempre chiosato da una spilletta antica al centro. Ma Carmela portava anche una collana di corallo rosso, antica, tagliate, le grosse perle, a sfaccettatura. Aveva dei golfini lavorati a mano, a punto riso, con le maniche a tre quarti, così come Antonio aveva dei gilet lavorati allo stesso punto, oppure a coste, di colori straordinari, giallo zafferano, verde oliva, o grigio mélange. Se il gilet era grigio, la lavorazione era a coste. Una eleganza da anni Quaranta, anni in cui le donne facevano ai ferri quasi tutto per la famiglia, sapientemente fatta proseguire nel tempo fino a farne quasi un marchio di eccentricità per l’artista pittore, la moglie del pittore, cui si aggiunse più tardi la compagnia della Signorina Azzoni, amica di famiglia venuta a vivere con i coniugi Calderara alla morte della zia con la quale aveva vissuto, morte coincidente con quella della madre di Antonio, che negli ultimi anni viveva con lui, in via Arpesani 7, al piano terreno di una casa dei primi del ‘900, completata da un ombroso piccolo giardino.
Nella vita di Calderara, così come lui sapientemente se l’era modellata, tutto coincideva con lo stile della sua arte. Anche la moglie, anche Annamaria, incarnavano una sua univoca scelta estetica, rinforzavano l’unità stilistica dettata, autorevolmente ma certo con graziosa prepotenza, da lui, patriarca ragionato e ragionevole, ironico, ma pur sempre patriarca, che aveva trovato nelle due donne, intelligenti ma innamorate del reciproco marito e amico di famiglia, ma anche maestro di pittura per un breve periodo, quella docilità nell’assecondarlo che gli era necessaria per plasmare anche le loro vite all’interno di un comune progetto, rendendole al contempo gratificate. Una grande maestria davvero!
Quando Sergio e io decidemmo di pubblicare edizioni numerate, più che altro per dare a Sergio una lavoro meno provvisorio e specialmente più remunerativo di quello di giovane e brillante sostituto gallerista, Calderara fu il primo artista cui chiedemmo di lavorare con noi, che non sapevamo molto, al di fuori delle nozioni di incisione che io avevo appreso nei corsi dell’Accademia di Brera, dove mi ero da poco diplomata. La mia prima personale l’avevo da poco tenuta proprio all’Indiano, con testo di Gillo Dorfles, nel 1964, pubblicato nel minuscolo pieghevole stampato su carta rosa, come provocazione scelta da Piero Santi per tutti i suoi inviti. Lui diceva ridendo, tanto per scoprire subito le carte: “Per me le donne sono come i cinesi, tutte uguali”.
Ma il nostro fervore e la curiosità, insieme ad una grande voglia di fare, ci condussero ad imparare in poco tempo come si fa una edizione numerata, che in quegli anni erano alla svolta tra classico e moderno, con l’entrata nel genere di mezzi di stampa un tempo relegati a quella industriale, avventura che Sergio ed io portammo alle estreme conseguenze del libro-oggetto, del multiplo, lavorando con grandi maestri delle avanguardie internazionali.
Fu così che una sera andammo a trovare Antonio nell’appartamento di via Arpesani.
Calderara era entusiasta dell’idea di creare un libro con le sue immagini, e voleva farci incontrare un suo giovane amico, un grafico e designer, professione in quegli anni non ancora molto chiara in Italia, dove non esistevano scuole di grafica, e neppure di design, un olandese che lavorava a Milano e che era appassionato di geometria e di matematica, Andrjes Van Onck, il quale si sarebbe occupato del testo che avrebbe spiegato in chiave matematica le sequenze cromatiche e lineari con le quali l’artista aveva rinnovato radicalmente il proprio linguaggio, altrimenti allineato nella scuola raffinata di quella tendenza del Novecento rivolta al realismo magico, un po’ alla Casorati, con la rarefazione metafisica senza il coraggio di introdurre elementi sovvertenti nella disposizione degli oggetti, così come fecero De Chirico e Savinio, che dettero dei canoni precisi alla metafisica.
La casa era speciale, tutta per il lungo, come il bassotto. Nella grande sala, tre finestre dalle inferriate dipinte in bianco, i mobili dell’Ottocento disposti geometricamente, con ogni spazio calibrato allo spasimo, e le regole della tradizionale disposizione del mobilio, trasgredite soltanto quello che basta per dare un aspetto estremamente studiato, immobile, iconograficamente rinascimentale direi, a ogni oggetto prelevato da un contesto antico e spiazzato, a causa dei colori delle stoffe, ma anche degli spazi. Di nuovo, di moderno, nelle case di Calderara non c’era nulla, ma totalmente nuovo era il suo modo di creare una atmosfera spirituale, in gran parte dovuta ai suoi dipinti astratti fatti di colore intensissimo e luminoso, pacati e allo stesso tempo inquietanti, proprio per quel quasi nulla che mettevano in evidenza.
La pittura monocroma sarebbe venuta a galla negli anni ’70, ma qui è tutta una altra storia. Le tavolette di piccole dimensioni, anche piccolissime, create dal Maestro fino alla sua morte, sono più simili a delle icone, dove quello che manca fa pensare alla totalità, mentre la scuola del monocromo si attesta su posizioni più laiche.
Tanto per cominciare un letto con due spalliere leggermente ricurve era stato stretto di parecchi centimetri, e allungato, in modo da diventare doppio. Ricoperto da un tessuto verde oliva, aveva tre piccoli rotoli dai profili giallo cromo, uno ai due estremi e uno al centro. Chiudeva la sala sul lato corto, e nessuno si sognava neppure di sedervisi, si capiva che era un oggetto inutile. Al capo opposto la sala era chiusa da un filare di aste nere, che andavano da terra al soffitto, oltre il quale era la scaletta che scendeva al seminterrato, nel quel si situava lo studio dell’artista. Dalla finestrina un tempo apribile sulla strada per il carico e scarico di eventuali merci, entrava la luce, poca in verità, ma forse di aiuto e comunque soddisfacente per i colori intensi ma allo stesso tempo soffusi delle pitture di Antonio, che sul minuscolo cavalletto, posato sul piano di parquet del soppalco, si offrivano alla vista, già impreziosite dal fatto di stare quasi su un altare, sopraelevate rispetto al piano di quella che pensandoci ora prendeva la valenza sacrale di una cripta. Lui diceva di essersi creato uno studio piccolo per forzarsi a fare quadri piccoli per non affaticarsi, dopo il terribile infarto che lo aveva colpito, ma è anche vero che aveva dipinto opere di piccola dimensione anche da giovane.
Per Sergio e per me tutto l’insieme rappresentava uno straordinario incontro con lo stile, uno stile che conglobava regole di vita, di convivenza e arte, dove la valenza estetica raffigurava l’ansia di perfezione cara all’artista, in equilibrio tra tradizione e trasgressione.
E il famoso salto che Antonio fece nelle braccia, non sempre accoglienti, dell’astrazione pura, fu il gesto di un coraggio meditato per anni, probabilmente, e non più contenibile, a fronte della osservazione delle ricerche astratto geometriche del Novecento, non certo ignorate anche se non condivise, affrontate infine, alla soglia della vecchiaia, come catarsi di una capacità di sintesi che, parrebbe un ossimoro ma non lo è, lo aveva sempre condotto nella propria ricerca, attraverso l’analisi minuziosa del circostante, del famoso lago d’Orta, del riflesso nell’acqua dell’isola, della contemplazione della luce del lago in tutte le ore del giorno e del crepuscolo.
Eliminando particolari scomodi per la composizione del dipinto, Antonio si ridusse all’essenziale, divenne veramente astratto, ma rimase crepuscolare.
Ricordo che una volta, nel suo studio di Vacciago, paesino dove anche io e Sergio comperammo una casa, affascinati da quella di Antonio, ma anche dal suo inimitabile stile di vita, commentando un suo quadro figurativo nel quale aleggiava una atmosfera metafisica, gli dissi che se non avesse dipinto un pezzo di casa, che si trovava sulla destra dell’opera, sarebbe stato meglio. Lui mi rispose, in milanese, la casa era lì, e ho dovuto dipingerla. Una ammissione sincera di colpevolezza nei riguardi dell’astrazione in seguito praticata con tanto rigore, che mi fece amare il mio anziano amico, con ancora più tenerezza.
Antonio era capace di dipingere di bianco un oggetto originale del Settecento, se gliene andava il ghiribizzo, per ricreare con quella base un altro oggetto, a lui più somigliante. Contribuiva al tutto, il lavoro di Carmela, da come allestiva la tavola da pranzo, tovaglia a quadretti bianco e nero oppure bianco e rosso per Vacciago, tovaglia di fiandra per Milano, al cibo che serviva. Cibo semplice, tradizionale. Tagliatelle fatte da lei sull’asse di noce stagionato che fungeva da piano dell’intero tavolo antico usato in cucina, piano che poteva essere lavato con candeggina, per eliminare ogni traccia di cibo, e riproporlo netto e disinfettato per l’uso. Ragù alla bolognese, o salsa di pomodoro con una foglietta di basilico. Se c’era il ragù c’era anche il parmigiano abbondante dentro nella formaggiera, se c’era il solo pomodoro invece, no. Arrosto, o pollo, o scaloppine, patate al forno perfettamente rosolate. Insalata dell’orto, che Antonio aveva fatto realizzare con vasconi posti in corsie strette che rialzassero la terra in modo da non doversi piegare troppo, tagliata finissima, con il giusto commento di non pochi e neppure tanti pomodori. Il modo in cui il tutto era cucinato, era semplicemente perfetto. Il vino lo sceglieva lui che, pur astemio, non lo sbagliava mai.
In quell’atmosfera che ci fece innamorare di Antonio progettammo due libri, i primi della nostra fortunata serie, protrattasi fino al ’73 nel lavoro comune, e in seguito continuata da me sola, questa volta a mio nome come editore, fino al 1985.
Il primo libro consiste in tavole sciolte di righe ortogonali stampate a secco, “Frequenze ortogonali”. Nei punti di incrocio tra le righe, si formarono dei quadratini, che Antonio dipinse a mano, all’acquarello. Tinte così leggere, impercettibili quasi, che alla fine, quando si trattò di raccogliere i fogli e distribuirli negli astucci editoriali, esaminandole una per una ci domandavamo se la passata di acquerello ci fosse, oppure se fosse stata dimenticata. Sì, la ghé, no, la ghé minga…e ridevamo. Io il milanese non l’ho mai saputo, ma fino a lì ci arrivavo, Sergio si compiaceva di parlarlo. Il testo lo chiedemmo a Giulio Carlo Argan, e lo stampammo in bianco, leggibile quel che basta. Argan firmò a mano tutta la tiratura, in un salottino dell’albergo Cavalieri, allora sull’angolo di via Larga. L’astuccio lo facemmo bianco. Come primo libro, di una casa editrice nata senza mezzi, solo con la nostra buona volontà e il nostro entusiasmo, insieme alla fiducia che alcuni grandi ci dettero, eravamo più che contenti, anche se non ne vendemmo neppure uno.
Il secondo libro invece, quello con il testo di matematica, era tutto stampato in giallo, compreso naturalmente il testo. Anche questo non fu un successo di vendita, anche perché non sapevamo proprio a chi, eventualmente, proporli, i nostri libri, che furono però un rodaggio perfetto e incoraggiante.
Un ferragosto, credo nel ’70, fummo ospiti di Carmela e Antonio nella casa di Vacciago, dove ora ha sede la Fondazione. La stanza degli ospiti era nel corpo che chiude il quadrato irregolare del cortile, rispetto alla attuale entrata, sulla sinistra. Due lettini, un inginocchiatoio, non ricordo esattamente quali altri arredi, ma ricordo la calma e l’armonia che provammo, vivendo due giorni in quella casa. E fu anche un po’ per caso che chiedemmo ad Antonio se non ci fosse qualche casa in vendita nel villaggio. Lui, aggrottando le sopracciglia, guardandoci al di sopra degli occhialini a metà calzati sul naso, sguardo già complice, ci fece attendere qualche istante denso di aspettativa, la sua risposta, – sì che la ghé –
Era la casa Pestalozza, quella appartenuta al Senatore del regno Ernesto, famoso ginecologo, titolare di una clinica, credo, a Firenze, e nientedimeno che, ginecologo della Regina Margherita. La sua ultima erede, Matilde, si era decisa a venderla, anche dietro consiglio di Antonio, che le suggerì di vendere la proprietà tenendo per sé l’usufrutto della casina a lato del giardino.
Le trattative furono abbastanza lunghe, perché Matilde lavorava all’epoca in Pakistan, e il tutto avvenne per procura, a opera del giovane nipote avvocato di Antonio, Beppe, ora presidente della Fondazione. La casa che volevamo era già stata visitata da un gallerista tedesco, sempre attraverso Calderara, ma alla fine Antonio ci favorì, pur di averci vicini, e, mi disse dopo, perse il contatto con il gallerista proprio per questa ragione.
Nel giro di un anno, ci trasferimmo a vivere a Vacciago, anche se non fu proprio una grande idea. L’isolamento che conveniva ad Antonio non conveniva a noi, che dovevamo comunque correre sempre a Milano e altrove, per stare dietro al lavoro delle edizioni, ai miei impegni di artista, alle relazioni internazionali senza le quali non si sarebbe fatto nulla di quanto facemmo. Il telefono ci fu collegato dopo un paio d’anni, e così andavamo a telefonare al bar. Gli artisti vennero a trovarci a Vacciago, anche il già anziano Man Ray con la moglie Juliet, passarono qui qualche giorno, e molti altri.
Si andava formando una sorta di cenacolo, che poneva in relazione chi veniva da noi e chi andava da Antonio, in uno scambio di relazioni davvero amichevole ed estremamente interessante, del quale ci compiacevamo a vicenda, costruendo così un piccolo mito relativo alla compresenza, nello stesso villaggio, di un anziano maestro e di due giovani dagli spigliati rapporti internazionali. Antonio in quegli anni cominciò ad avere successo come astrattista, iniziando una seconda vita, che lo riempì di allegria, di compiacimento, togliendolo dalla polvere provinciale nella quale aveva suo malgrado vissuto per troppo tempo.
La sua passata militanza nelle fila, sia pure appartato, dei figurativi, come dicevo prima, di quel novecentismo del realismo magico, ma anche del chiarismo lombardo, lo mise, per quegli estimatori che si era andato a fatica formando negli anni, dalla parte dei traditori. Oggi pare strano, ma la divisione tra figurativo e astratto era ancora assai presente, perfino negli anni ’70. Ma c’era assai forte la voglia di storicizzare le avanguardie, gli stili, i primati delle idee e delle innovazioni, non essendo ancora iniziato il post-moderno, che rimescola ogni cosa rendendo ripescaggi e contaminazioni non solo legittimi ma necessari.
Lui perse i contatti con le gallerie, ricordo Barbaroux e Schettini, con il quale aveva per anni lavorato e scambiato, opere contro pellicce, essendo Schettini pellicciaio oltre che gallerista, perse i propri collezionisti. In cambio, acquistò una dimensione europea assolutamente repentina e straordinaria. Galleristi tedeschi, olandesi, svizzeri, presero a visitarlo, proprio a Vacciago dove nel frattempo si era trasferito a vivere anche in inverno, dove l’atmosfera della casa e dello studio e delle opere, si fondeva in un unico argomento di seduzione, comprese Carmela e Annamaria, che fungeva da interprete, per il tedesco, e da segretaria. Annamaria scriveva a macchina, telefonava, ma specialmente possedeva una automobile, che guidava anche per lunghi viaggi che il gruppo affrontava, sempre con un cane bassotto, ne ricordo uno nero dal pelo lucido e vezzeggiatissimo, recandosi nelle città dove venivano allestite mostre personali dell’anziano maestro, che nell’atteggiamento, nella felicità per il meritato successo, si mostrava giovane e fresco, mescolato, come solo nel mondo dell’arte avviene, alle più giovani generazioni.
 La casa di Calderara, allora, consisteva nella fetta attualmente sede principale della Fondazione, quella dai tre ordini di archi e colonne di granito, cinquecentesca. Vi si entrava da una porticina, ora chiusa ma ancora visibile all’esterno, dal vicolo, e si accedeva al primo piano, sotto al portico pavimentato di piastrelle di graniglia rosa antico, così come tutto il resto della casa. A quel piano, il grande salotto con il pianoforte a coda, sempre con un mazzo di fiori freschi posato sul piano, accanto alla foto della bambina. Gabriella, la figlia amatissima, morta ancora bambina di un male che ora si cura, attorno alla quale si era costituito un ritorno all’ordine dell’anarchico Antonio che conviveva con Carmela, cosa che allora in una famiglia borghese non era certo ben vista, e fu la madre di Antonio, così lui mi raccontò, che alla nascita di Gabriella gli disse, “ti adess ti te la spuset”, e così fu. La famigliola visse, da quanto mi dicevano entrambi, assai semplicemente, poveramente perfino, durante la guerra sia a Vacciago, nella casa paterna, poi venduta ad un editore tedesco, Hans Müller, anche lui fanatico ammiratore di Antonio, sia nella torre di Pella, dall’altro lato del lago. Ad aiutare economicamente Antonio provvedeva suo fratello, commerciante in pellami, che lui definiva “il mio Theo”, il che gli consentiva di vivere la vita dell’artista puro, dipingere le scene di vita familiare, il lago, le piccole nature morte, qualche ritratto. Uno dei più belli è il ritratto del padre, una massa nera, semplificata e allo stesso tempo eloquente anche come aneddoto. Ma i due ritratti di Carmela, toccano, a mio parere, la vetta dell’arte figurativa di Antonio. Quello in cui lei ha un abito da sera rosa, lo scollo modesto sigillato da un grande fiocco, le mani in grembo. Il collo lungo, allora perfettamente liscio, il volto triangolare, dominato dall’azzurro degli occhi grandissimi, esageratamente grandi, dallo sguardo enigmatico di chi vorrebbe dire cose che non può dire. Un dipinto realizzato con minuscole pennellate, per dare all’insieme una sfumatura, forse dettata dal rosa dell’abito, che diede all’insieme una luce d’alba innaturale che soffonde l’intero spazio accostato alla figura della donna. E poi c’è Carmela con un abito bianco e rosso, geometrico nel disegno, che mi ricorda un po’ l’abito del Signor Bonaventura del Corriere dei Piccoli, i giganteschi guanti alla moschettiera, la mano posata a ventaglio sul bracciolo della poltrona ottocentesca, lo sfondo di una finestra dalla quale si stagliano le campiture dai colori acidi attribuito a parti di realtà geometrizzate e ancora perfettamente riconoscibili, premessa di quella astrazione che arriverà molti anni dopo.
La casa di Calderara, allora, consisteva nella fetta attualmente sede principale della Fondazione, quella dai tre ordini di archi e colonne di granito, cinquecentesca. Vi si entrava da una porticina, ora chiusa ma ancora visibile all’esterno, dal vicolo, e si accedeva al primo piano, sotto al portico pavimentato di piastrelle di graniglia rosa antico, così come tutto il resto della casa. A quel piano, il grande salotto con il pianoforte a coda, sempre con un mazzo di fiori freschi posato sul piano, accanto alla foto della bambina. Gabriella, la figlia amatissima, morta ancora bambina di un male che ora si cura, attorno alla quale si era costituito un ritorno all’ordine dell’anarchico Antonio che conviveva con Carmela, cosa che allora in una famiglia borghese non era certo ben vista, e fu la madre di Antonio, così lui mi raccontò, che alla nascita di Gabriella gli disse, “ti adess ti te la spuset”, e così fu. La famigliola visse, da quanto mi dicevano entrambi, assai semplicemente, poveramente perfino, durante la guerra sia a Vacciago, nella casa paterna, poi venduta ad un editore tedesco, Hans Müller, anche lui fanatico ammiratore di Antonio, sia nella torre di Pella, dall’altro lato del lago. Ad aiutare economicamente Antonio provvedeva suo fratello, commerciante in pellami, che lui definiva “il mio Theo”, il che gli consentiva di vivere la vita dell’artista puro, dipingere le scene di vita familiare, il lago, le piccole nature morte, qualche ritratto. Uno dei più belli è il ritratto del padre, una massa nera, semplificata e allo stesso tempo eloquente anche come aneddoto. Ma i due ritratti di Carmela, toccano, a mio parere, la vetta dell’arte figurativa di Antonio. Quello in cui lei ha un abito da sera rosa, lo scollo modesto sigillato da un grande fiocco, le mani in grembo. Il collo lungo, allora perfettamente liscio, il volto triangolare, dominato dall’azzurro degli occhi grandissimi, esageratamente grandi, dallo sguardo enigmatico di chi vorrebbe dire cose che non può dire. Un dipinto realizzato con minuscole pennellate, per dare all’insieme una sfumatura, forse dettata dal rosa dell’abito, che diede all’insieme una luce d’alba innaturale che soffonde l’intero spazio accostato alla figura della donna. E poi c’è Carmela con un abito bianco e rosso, geometrico nel disegno, che mi ricorda un po’ l’abito del Signor Bonaventura del Corriere dei Piccoli, i giganteschi guanti alla moschettiera, la mano posata a ventaglio sul bracciolo della poltrona ottocentesca, lo sfondo di una finestra dalla quale si stagliano le campiture dai colori acidi attribuito a parti di realtà geometrizzate e ancora perfettamente riconoscibili, premessa di quella astrazione che arriverà molti anni dopo.
Jesus Soto, allora artista emergente dell’avanguardia cinetica, ce lo fece conoscere proprio Calderara, incitandoci ad andarlo a trovare, nel corso di un nostro soggiorno a Parigi. Diventammo amici di Soto, con il quale lavorammo per anni, non solo come editori ma anche realizzando a Milano, con artigiani semi industriali da coordinare, i suoi grandi progetti di integrazione all’architettura, per i quali era d’obbligo trovare soluzioni tecniche di notevole portata. Grandi sculture, chilometri di bacchette verniciate, che poi andavamo ad installare, sia in Venezuela che altrove. E Soto soggiornava da noi, sia a Milano che a Vacciago, dove ci si incontrava con Calderara, che proprio in quegli anni andava realizzando il suo intento di avere, alla sua morte, una fondazione che assicurasse visibilità alla sua casa, alla sua opera. La fondazione doveva essere costituita dalle opere degli artisti amici di Calderara, con i quali lui avesse una comunione di poetica, di intenti, e non solo di amicizia personale, cosa che comunque aveva con quasi tutti i viventi da lui incontrati.
Sono stati molti i pomeriggi passati a parlare, progettare, nello studio di Antonio al terzo piano. Il portico ospitava un lettino di legno grezzo, una mania che ereditai da lui fu quella di decapare i mobili antichi per lasciarli con il colore originario del legno, impoveriti dalla superbia delle patine e della cera, con un materasso di tela bianca, e i fiocchetti di lana, anziché bianchi, rossi. Su quel lettino lui si sdraiava a riposare, a pensare. Anche io, nelle mie case, ho sempre un letto su cui sdraiarmi a leggere, così come imparai da Antonio. A muro stavano invece i quadri dipinti a olio, ad asciugare, anche da un anno all’altro. Perché Calderara dipingeva a velature, e l’olio impiega tempo ad asciugare. Il colore cresceva di intensità ma anche di lievità di luminosità, in virtù dei molteplici strati, distribuiti con pennello morbido, tirando perfettamente il colore. E altrettanta, anzi maggiore, precisione, era richiesta dalle righe sottili, dai quadratini dove il colore cambiava, magari sempre delle stesso colore di base, ma di tonalità più chiara, o più scura. Per andare diritto lungo le righe, usava la stecca cui appoggiare il braccio, secondo tradizione. Il passaggio poi, tra una stesura e l’altra di colore, della carta smeriglia più sottile, sfumava solo impercettibilmente i contorni, aiutando quell’aria rarefatta, a suo modo naturalistica, che differenziò con successo l’astrazione di Calderara da ogni più asettica ricerca concertista a lui maestra, più che altro per l’anticipo, rispetto a lui, con la quale venne creata.
Nello studio all’interno, il cavalletto stava sotto alla lunga finestra che dal lato sinistro portava luce proprio dove serviva. Una sedia, simile a quelle di Chiavari, leggera, dipinta di bianco, era quella sulla quale sedeva Antonio per lunghi pomeriggi, fino a quando la luce naturale gli consentiva di dipingere, un cuscino a quadretti sulla paglia. E gli scaffali con le opere finite e regolarmente incorniciate, i libri d’arte, selezionatissimi, che denotavano i suoi amori quasi maniacali, comunque monotematici. La riproduzione in bianco e nero di due opere di Piero della Francesca, e la foto di Gabriella.
Nel tempo il dolore per la morte della bambina gli aveva offerto la ragione per giustificare -ma meglio sarebbe dire avvalorare– il suo passaggio alla astrazione, così come lui lo spiegava, come un anelito all’assoluto, al nulla dell’assenza. E Antonio aveva nei riguardi della morte della bambina un atteggiamento mistico, “tu ora sei la luce” mi pare che scrivesse in un suo testo, perché, sempre negli ultimi anni della propria vita, scrisse brevi testi, poetici e in un certo senso teorici, che nella loro semplicità bene esprimono il suo pensiero.
Iniziarono così gli scambi con gli artisti amici. Un quadro, o un acquarello, o più acquarelli di Calderara, contro un lavoro dell’altro artista, senza badare a che fosse famoso o ancora in fieri, oppure anche poco noto. Intelligentemente Calderara andava costruendo attorno a sé un mondo di ricerca parallela o incrociata che lo contestualizzava nell’ambito della ricerca astratta internazionale. Capace, con il proprio intuito, di collezionare anche la famosa scatoletta di merda d’artista di Piero Manzoni, di cui ammirava la genialità trasgressiva, accanto alla linea infinita, all’impronta sull’uovo, reliquie del pensiero di quegli anni, concettuali di origine dadaista, custodite dentro una bacheca costruita sulle gambe di un tavolo stile fratino, antico. E accanto a Manzoni troviamo un piccolo blu di Yves Kline, che Sergio e io scambiammo con un suo lavoro. E cambiai un inginocchiatoio per un acquarello, una poltroncina gliela regalai senza cambio, e non ricordo cosa mi dette in cambio del salottino ottocentesco che ancora figura nelle sale della collezione, e scambiai un suo piccolo olio con una mia scultura.
Grande numero di scambi Antonio effettuò con Soto, che lo adorava, stringendogli il volto tra le sue lunghe dita, e baciandolo in fronte, quando lo incontrava.
Anche il nostro amico, poeta e mercante d’arte, Jean Claude de Fuegas, adorò Antonio, scrisse una serie di poesie per il suo lavoro che noi pubblicammo accompagnate da serigrafie di Antonio, e gli fornì quel piccolo ma prezioso Sonia Delaunay che figura nella Fondazione, oltre ad una carta della Gontcharova.
Con la autorevolezza di Soto, che lo propose per primo, lavorammo affinché la grande Denise René si interessasse al lavoro di Calderara. Denise arrivò anche lei a Vacciago, accompagnata dal suo socio ed amante Hans Mayer, con galleria a Düsseldorf, ed entrambi lo esposero con successo. Per la mostra a Parigi Denise commissionò a noi il catalogo, così come avvenne più tardi, quando Sergio e io riuscimmo a fare innamorare del lavoro del nostro amico anche Carla Panicali, che dirigeva la Galleria Marlborough di Roma, succursale delle prestigiose sedi di Londra, e di New York. Ricordo quando nella casa studio che avevamo a Milano in via S.Gregorio, di fronte al grande olio verde scuro che Antonio ci aveva regalato per il matrimonio, Carla si convinse della poesia che Calderara metteva nella ricerca astratto geometrica, della sua originalità, e desiderò esporlo.
Quella poesia rifiutata dai grandi teorici dell’arte concreta, e affettuosamente ammirata in lui da Max Bill e Lohse per i quali Calderara nutriva una venerazione seconda solo a quella per Josef Albers, che gli erano amici e che lo proteggevano, cosa alquanto inusitata nel mondo dell’arte, che non è fatto di agnelli.
Quei maestri non avevano nulla da temere dal nuovo del maestro italiano, che arrivava non certo come partecipe di una ricerca che ebbe la propria avanguardia già alla metà degli anni ’30, bensì come un fenomeno a parte, assai italiano, come è molto italiano un altro artista al di fuori dalle avanguardie come Morandi, e proprio per questo tanto amato da tutti.
 Organizzai nella casa di Vacciago, parecchie cene, e feste più grandi, per onorare la nostra amicizia, farlo incontrare con i nostri ospiti, per fare divertire Antonio, che spesso veniva a trovarmi di mattina, per raccontarmi cosa aveva sognato. In estate c’era anche lo storico dell’arte Frederich Ekmanns, che trascorreva le vacanze con i suoi due figli ancora piccoli, alloggiando all’albergo Maulini, a Vacciago, e passando molto tempo con Calderara, anche per allestire con lui una strategia di mostre in musei e gallerie che gli assicurassero la notorietà in Germania. Per questo uomo di cultura e anche di un certo potere, Calderara divenne una autentica passione, fece molto per il suo lavoro, e una volta in pensione, venne ad abitare proprio qui, a Vacciago, dove sta ancora.
Organizzai nella casa di Vacciago, parecchie cene, e feste più grandi, per onorare la nostra amicizia, farlo incontrare con i nostri ospiti, per fare divertire Antonio, che spesso veniva a trovarmi di mattina, per raccontarmi cosa aveva sognato. In estate c’era anche lo storico dell’arte Frederich Ekmanns, che trascorreva le vacanze con i suoi due figli ancora piccoli, alloggiando all’albergo Maulini, a Vacciago, e passando molto tempo con Calderara, anche per allestire con lui una strategia di mostre in musei e gallerie che gli assicurassero la notorietà in Germania. Per questo uomo di cultura e anche di un certo potere, Calderara divenne una autentica passione, fece molto per il suo lavoro, e una volta in pensione, venne ad abitare proprio qui, a Vacciago, dove sta ancora.
In uno dei nostri incontri -mi ero già separata da Sergio e vivevo sola nella casa, anche se non tutto l’anno avendo comprato da Antonio il suo appartamento milanese di via Arpesani 7 da me trasformato in studio con possibilità di abitarci- decidemmo di ideare un premio, intestato a Raffaello Giolli, critico d’arte amico di Calderara, importante quanto dimenticato, morto giovane in un campo di concentramento, al pari del suo giovane figlio. Avevano passato la guerra a Vacciago, allestendo anche corsi di storia dell’arte per gli sfollati, ma la protezione di questo luogo appartato non valse loro la salvezza, quando ormai stava per finire la paura delle deportazioni degli ebrei. Feci in tempo a conoscere Rosa Giolli, eccentrica signora che aveva, negli anni ’30, lavorato come tessitrice, creatrice di quelle arti minori che fecero eco alle ricerche più accreditate operate dagli artisti maschi e che, unghie lunghissime, capelli scarmigliati, ammantata in un kimono, viveva con pochi mezzi e certo molte visioni nelle stanze della casa di Vacciago che vedo dalle mie finestre, tra bellissimi mobili e libri importanti, ora dispersi, dopo la sua morte. Una estate Pol Bury, artista cinetico emergente, e il suo amico André Balthazar, con il quale creava edizioni numerate, Daily-bull, di ispirazione patafisica, affittarono delle stanze da Rosa, e anch’essi divennero amici di Calderara. Per il premio intestato a Raffello Gialli con molta semplicità, seduti attorno al tavolo della mia cucina, formammo una giuria. Calderara, io, Andrea Cascella, Kengiro Azuma. Artisti, amici, tutti con una casa dalle parti di Vacciago. Avremmo deciso ogni anno a chi attribuire il premio, che sarebbe stato una opera di ognuno di noi, a rotazione. Il primo ad offrire il premio fu naturalmente Antonio, e di comune accordo lo assegnammo a Dadamaino. Seguirono Gianni Colombo, e Pietro Coletta. La festa durava un giorno, con qualche opera esposta nelle due stanze che nella mia casa danno sul vicolo, antico ingresso della casa ma in disuso da tempo, anche a causa della umidità che mi impedì di lasciarvi le opere più a lungo di una giornata. Io cucinavo per almeno duecento persone, avendone la forza e l’entusiasmo, e anche Carmela mi dava una mano, facendo qualche piatto nella sua cucina.
Antonio si era già trasferito nella parte di casa che chiude il quadrato del cortile, e che si affaccia sulla minuscola piazzetta, per la quale disegnò una tavola di pietra, due appoggi, una scultura in granito e acciaio, e il luogo per un cipresso, che sta lentamente diventando sempre più alto. Lo studio era stato trasferito, stessa posizione, luce simile, stessa sedia, stesso cuscino, stessi scaffali, stesse riproduzioni di Piero della Francesca. Aveva installato l’ascensore tra un piano e l’altro. Al piano terreno dormivano in due letti antichi Antonio e Carmela, divisi da una tenda di velo dalla parte dove dormiva Annamaria. La cucina realizzata con sportelli antichi all’interno di scaffalature in formica bianca, il tavolo per le tagliatelle, i fornelli più piccoli e nel giardino, il camino per il girarrosto. Nella piccola sala da pranzo si poteva ancora sedere al tavolo rotondo, e la saletta per la televisione, dominata dal ritratto di Carmela vestita di rosa, si avvale ancora di un mobile del Settecento dipinto di bianco, al pari di due angeli che reggono una mensola, così come passato di bianco è il divanetto dal sedile di paglia, e le due sedie. Piccoli spazi, pensati, mi diceva Antonio, anche per quando le due donne sarebbero rimaste da sole.
Malato di cuore, Antonio non volle farsi mettere il pace-maker.
Mi ero nel frattempo legata di amore con Getulio Alviani, anche lui, da tempo, amico di Antonio, che andammo a trovare prima di partire per una vacanza in Sicilia. Da tempo lui non usciva più, privo di forze rimaneva a letto, aspettando la morte con estrema serenità. Aveva sistemato tutto, creata la Fondazione, trovato a chi affidarne la cura, appeso secondo i suoi criteri tutte le opere, le proprie al primo piano, quelle degli amici nelle altre stanze, e le sculture che possono stare all’aperto nel cortile tenuto da Carmela con il prato di solo timo, nel quale si aggirava la tartaruga Gertrude. Vedendoci, Antonio sorrise. Io gli dissi che andavo al mare in Sicilia, ma che sarei tornata presto. “Mandami una cartolina con il Getulio vestito da marinaio”, mi disse sorridendo specialmente con i suoi occhi dardeggianti, luminosi di ironia, fino all’ultimo.
Erano giorni che non parlava più, e quelle, mi disse Carmela, furono le sue ultime parole.
(Questo articolo sarà pubblicato nel II volume di Fogli/e Scritte, a cura di Davide Vanotti).


Un Commento