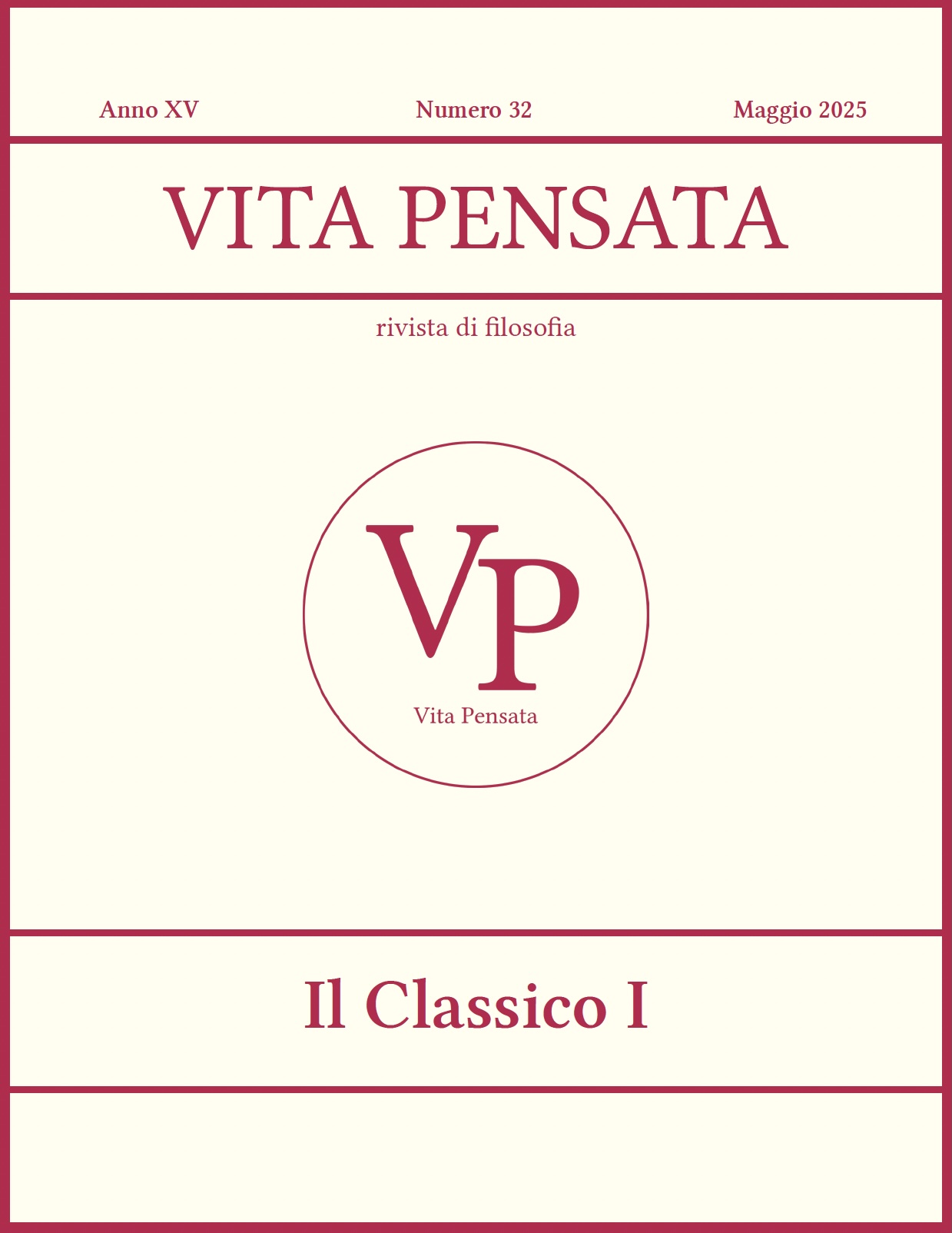By: Daria Baglieri
Abstract
Il saggio indaga la concezione della soggettività come “spaccatura del mondo” nella Fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty, fondata sulla corporeità vissuta (Leib, chair) come intreccio di abitudine e spontaneità in una memoria incarnata. La soggettività come “spaccatura” è insieme apertura al mondo e differenza di sé con sé nel tempo, un’“intermittenza” tra il nascere e il morire che per un attimo si sente e si sa senziente.
The idea of subject as a “gap of the world” in Merleau-Ponty’s Phenomenology of Perception is explored. This notion is rooted on the lived body (flesh, … Continua a leggere »
By: Kristof K.P. Vanhoutte
Abstract
E se la concezione comunemente accettata del ‘classico’ fosse parziale? Se la sua funzione-modello non fosse quella che solitamente percepiamo? Forse nel concetto di ‘classico’ c’è di più di quanto pensiamo. Questo testo sfida la comprensione tradizionale del ‘classico’ come modello, proponendo che la sua funzione possa essere più limitata ed erratica di quanto comunemente riconosciuto. Attraverso un’analisi delle opere di Giorgio Agamben, Thomas Kuhn e Michel Foucault, il saggio esplora come i paradigmi plasmino la portata e i limiti del ‘classico’. Sostiene che la funzione del ‘classico’ sia più strettamente legata alla conformità e al pragmatismo che … Continua a leggere »
By: Marica Magnano San Lio
Abstract
Questo contributo intende riflettere su talune rivisitazioni della ‘filosofia pratica’ di Aristotele che si colgono in alcune pagine della cultura tedesca del Novecento. In questo periodo si assiste, infatti, ad un rinnovato interesse per la praxis aristotelica, specie per la nozione di phronesis, che viene reinterpretata da pensatori quali Hans-Georg Gadamer, Joachim Ritter, Rüdiger Bubner e Günther Bien, nell’ambito di una più generale “riabilitazione della filosofia pratica”. Se Gadamer pone la phronesis come modello dell’ermeneutica, Bubner la interpreta come unica forma di razionalità pratica, soffermandosi, come Ritter e Bien, sul concetto di ethos quale fondamento dell’etica aristotelica. … Continua a leggere »
By: Ida Scebba
Abstract
Questo saggio affronta il tema del classico a partire da una prospettiva critica che ne mette in discussione l’identificazione con l’ideale apollineo di bellezza, misura e armonia, affermatosi con la tradizione winckelmanniana. Attraverso la visione di studiosi quali Nietzsche e Warburg, il contributo propone una rilettura del classico come spazio di tensione e inquietudine, dove convivono istanze contrastanti, in particolare quelle riconducibili alla polarità tra apollineo e dionisiaco. Il testo si articola in due momenti principali: una prima parte che analizza la genealogia del concetto di classico e la sua progressiva semplificazione in epoca moderna; una seconda parte … Continua a leggere »
By: Michele Del Vecchio
Abstract
Lo scopo della ricerca è quello di evidenziare il ruolo svolto dal canone classico e la sua presenza nella architettura europea. Le tappe del percorso sono le seguenti: definizione di classico in rapporto al mondo antico greco-romano; Umanesimo e Rinascimento; Palladio; Neoclassicismo.
The paper focuses on the history of European architecture from its origins in classical Greece till the end of the XVIII century. Its aim is to highlight the role of the classical canon and its presence in European architecture through different stages: the definition of classical in the ancient Greek and Roman world; Humanism; Renaissance; Palladio; Neoclassicism.… Continua a leggere »